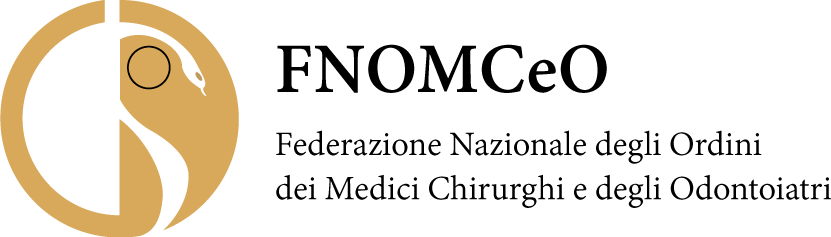In molte storie raccontate da film e romanzi contemporanei, agenti infettivi modificati geneticamente sono usati come strumento di minaccia o ricatto da parte di organizzazioni militari, terroristiche o criminali, oppure sfuggono accidentalmente al controllo degli scienziati provocando terribili pandemie. È comprensibile quindi che il pubblico guardi con preoccupazione a esperimenti di questo tipo, evocati fin da gennaio 2020 come possibile scenario nel quale ambientare la comparsa di SARS-CoV-2 a Wuhan.
Tra i film più famosi che hanno avuto come protagonista un virus modificato geneticamente c’è Mission Impossible 2, dove l’agente infettivo messo a punto da un gruppo criminale si chiamava “Chimera”, come la figura mitologica caratterizzata dall’avere parti del corpo di diversi animali. In tal modo si chiamano, più genericamente, tutti gli organismi costruiti in laboratorio assemblando caratteristiche di specie diverse. Appartiene a questa categoria il coronavirus creato all’Università di Boston di cui si è parlato nelle ultime settimane, che ha riportato l’attenzione dell’opinione pubblica sul controverso dibattito riguardo alle ricerche “gain of function” (“guadagno di funzione”, interventi capaci cioè di potenziare o conferire a un essere vivente proprietà che non aveva in natura) [1,2].
Dottore, cosa significa che una ricerca è “gain of function”?
Questo tipo di ricerca di per sé non evoca in genere nessuna obiezione quando la funzione acquisita serve a prevenire o curare malattie: gli scienziati hanno infatti modificato molti virus, batteri o lieviti per produrre antibiotici, vaccini o farmaci, tra cui l’insulina utilizzata dai pazienti diabetici. La disputa riguarda quindi soprattutto i casi in cui questa ricerca è condotta su agenti infettivi pericolosi che potrebbero, volontariamente o no, creare danni alle persone.
 Nel caso del virus chimera prodotto a Boston si discute se l’esperimento effettivamente appartenga a questo ambito, molto più strettamente regolamentato rispetto al resto della ricerca sui virus. Gli scienziati, infatti, hanno inserito sul virus originale di Wuhan, che nei topi è sempre letale, le “punte”, cioè le proteine “spike” della variante Omicron, che lo è molto meno. Il risultato è stata appunto una particella virale “chimera” con una letalità inferiore a quella originale (si stima infatti all’80% circa contro il 100% di quella di Wuhan), ma comunque molto più aggressiva della variante Omicron, almeno sui topi.
Nel caso del virus chimera prodotto a Boston si discute se l’esperimento effettivamente appartenga a questo ambito, molto più strettamente regolamentato rispetto al resto della ricerca sui virus. Gli scienziati, infatti, hanno inserito sul virus originale di Wuhan, che nei topi è sempre letale, le “punte”, cioè le proteine “spike” della variante Omicron, che lo è molto meno. Il risultato è stata appunto una particella virale “chimera” con una letalità inferiore a quella originale (si stima infatti all’80% circa contro il 100% di quella di Wuhan), ma comunque molto più aggressiva della variante Omicron, almeno sui topi.
L’esperimento ha creato allarme, e non solo perché si è parlato in maniera poco corretta di un virus con l’80% di letalità, lasciando intendere che ciò riguardasse i pazienti. Il dato invece riguarda solo topi, i quali muoiono sempre quando incontrano il virus originale, cosa che agli esseri umani non succedeva nemmeno a gennaio 2020, quando si trattava di un agente infettivo totalmente sconosciuto. Da questo punto di vista si potrebbe quindi anche sostenere, come hanno fatto gli autori del lavoro, che non si tratta di un “guadagno”, ma di una “perdita” di funzione, che cioè hanno attenuato il virus di Wuhan.
Dal momento però che il virus originale di Wuhan non è più in circolazione, altri sostengono che la chimera creata dai ricercatori americani vada valutata con riferimento alla variante Omicron, rispetto alla quale è molto più aggressiva. Da questo punto di vista si tratta quindi, a tutti gli effetti, di un guadagno di funzione, e di un aumento di pericolosità, a confronto con la minaccia rappresentata dalle varianti attuali di SARS-CoV-2.
Dottore, perché si fa questo tipo di ricerca?
La domanda che si sono posti tutti, quindi, è se il gioco valga la candela. Per qualcuno si tratta di un’attività troppo pericolosa per essere consentita, dal momento che i suoi risultati possono arrecare un danno involontario in caso di incidenti, oppure essere sfruttati da malintenzionati di ogni genere. Altri invece sottolineano che ricerche di questo genere permettono di conoscere meglio le minacce che ci circondano, così da poter prevenire nuove pandemie e creare vaccini e cure più efficaci.
Lo studio in questione, per esempio, è importante perché ha dimostrato che la virulenza di SARS-CoV-2 non risiede solo nella proteina spike, la parte del virus più studiata, contro cui si sono messi a punto vaccini e anticorpi monoclonali. Se l’aggressività clinica del virus non dipende dal fatto di avere le punte dell’una o dell’altra variante significa che ci sono altri meccanismi da studiare, e quindi nuovi bersagli da trovare per mettere a punto trattamenti più efficaci.
Dottore, ma è vero che questo dibattito non è nuovo?
Il primo violento dibattito su questo tema si è svolto a partire dalla fine del 2011, quando due diversi gruppi, uno olandese e uno negli Stati Uniti, annunciarono di essere riusciti a trasmettere facilmente tra i mammiferi il virus dell’influenza aviaria H5N1 [3,4]. Questo agente infettivo è da circa vent’anni un sorvegliato speciale, perché nei rari casi in cui si trasmette agli esseri umani è in grado di uccidere fino alla metà delle persone infettate. Finora, per nostra fortuna, non ha però acquisito la capacità di trasmettersi facilmente tra uomini e donne come fa, per lo più in maniera asintomatica, tra gli uccelli selvatici; mentre nel pollame provoca una malattia molto contagiosa.

Il tema è di particolare attualità in questi mesi, perché gravi epidemie di influenza aviaria ad alta patogenicità stanno colpendo gli allevamenti di Europa e Stati Uniti, e gli abbattimenti che si rendono necessari per cercare di controllare l’infezione stanno suscitando polemiche e proteste. Purtroppo non abbiamo i mezzi per curare questa malattia, e lasciar circolare il virus, come dovremmo aver imparato con SARS-CoV-2, facilita la formazione e la selezione di varianti spesso più contagiose.
In che modo gli studi di dieci anni fa possono tornare utili in questa situazione? Sapere che solo cinque – in alcuni casi anche quattro – mutazioni ci separano da un virus che potrebbe diffondersi facilmente tra gli umani impone maggiore prudenza e non ci fa vagare nel buio. Conoscere quali sono queste mutazioni permette di sorvegliare la loro eventuale insorgenza così da intervenire in maniera più radicale qualora si comincino a osservare nelle varianti isolate dagli animali infetti. Tutto ciò potrebbe quindi servire a prevenire nuove pandemie, ben più gravi di questa. Lo stesso vale per le migliaia di coronavirus potenzialmente trasmissibili agli umani già esistenti in natura [5].
Dottore, possiamo stare tranquilli?
Quando si pensa di vietare un filone di ricerca nei Paesi democratici, occorre sempre tenere conto che le stesse limitazioni non vengono imposte da parte dei governi di regimi autoritari, o da gruppi terroristici potenzialmente interessati a coltivare la propria capacità di guerra biologica. In altre parole, bandire del tutto questo tipo di ricerca sui virus più pericolosi dai laboratori occidentali non impedirà ad altri di portare avanti gli stessi studi, probabilmente in minori condizioni di sicurezza. Viceversa, proseguire il cammino della conoscenza anche nei confronti di questi agenti infettivi, perfino mettendo alla prova la loro capacità di diventare più pericolosi, potrebbe aiutarci a difendere meglio l’umanità da minacce infettive provenienti dalla natura, da incidenti o da chi volesse praticare atti di guerra biologica o bioterrorismo.
Perché la bilancia tra rischi e benefici penda a favore di questi ultimi occorre tuttavia che questi esperimenti vengano condotti in laboratori di massima sicurezza, senza dare spazio a nessuna eccezione o leggerezza. Su questo occorre che i governi e la comunità scientifica continuino a vigilare.