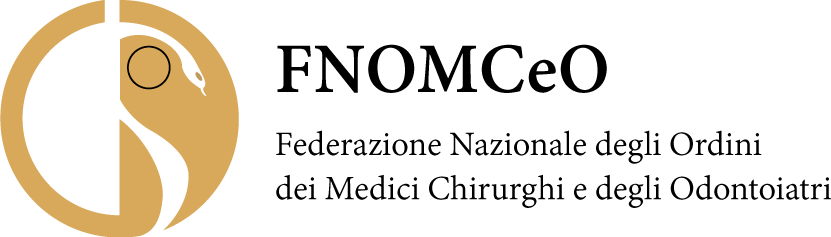Come la prendereste se il vostro medico vi prescrivesse una terapia fasulla, che non ha neanche l’ombra di un principio attivo? Probabilmente non molto bene. Tuttavia, in medicina può accadere anche questo e un comportamento del genere può avere delle motivazioni assolutamente scientifiche. Il cosiddetto “effetto placebo”, infatti, non solo è reale, ma in alcuni casi è persino utilizzato come strumento terapeutico.
In cosa consiste esattamente?
 Iniziamo dalle definizioni. Per placebo si intende una sostanza o una procedura non attiva (sia in positivo che in negativo) nei confronti della condizione per cui viene utilizzata. L’effetto placebo, invece, è la reazione che l’assunzione di un placebo determina sulla salute dell’individuo. Per esempio: il miglioramento dei sintomi associato all’assunzione di una terapia assolutamente inerme e inutile da un punto di vista fisiologico. Questo tipo di interventi ha un ruolo fondamentale in ambito sperimentale, dove è utilizzato come termine di paragone in tutti gli studi clinici finalizzati a stabilire l’efficacia di una nuova terapia. L’effetto placebo, tuttavia, non riguarda solo le terapie “fasulle” ma tutte le procedure mediche: ogni trattamento, anche farmacologico, produce infatti un effetto che è legato all’idea stessa del suo potere curativo. Quando si prende un’aspirina, ad esempio, una parte della sua efficacia è legata al principio attivo in essa contenuto, mentre un’altra dipende dall’idea stessa che l’aspirina faccia bene.
Iniziamo dalle definizioni. Per placebo si intende una sostanza o una procedura non attiva (sia in positivo che in negativo) nei confronti della condizione per cui viene utilizzata. L’effetto placebo, invece, è la reazione che l’assunzione di un placebo determina sulla salute dell’individuo. Per esempio: il miglioramento dei sintomi associato all’assunzione di una terapia assolutamente inerme e inutile da un punto di vista fisiologico. Questo tipo di interventi ha un ruolo fondamentale in ambito sperimentale, dove è utilizzato come termine di paragone in tutti gli studi clinici finalizzati a stabilire l’efficacia di una nuova terapia. L’effetto placebo, tuttavia, non riguarda solo le terapie “fasulle” ma tutte le procedure mediche: ogni trattamento, anche farmacologico, produce infatti un effetto che è legato all’idea stessa del suo potere curativo. Quando si prende un’aspirina, ad esempio, una parte della sua efficacia è legata al principio attivo in essa contenuto, mentre un’altra dipende dall’idea stessa che l’aspirina faccia bene.
L’effetto placebo viene sfruttato in ambito clinico?
Più di quanto si pensi. Innanzitutto, come detto in precedenza, l‘effetto placebo ha un ruolo fondamentale in ambito di ricerca, come termine di paragone per valutare l’efficacia e la sicurezza di un trattamento in fase di sperimentazione. Ma questo non è il solo utilizzo: secondo i risultati di uno studio del 2010, in cui sono stati raccolti i dati provenienti da 22 sondaggi condotti in 12 Paesi, è emerso che una percentuale compresa tra il 17% e l’80% dei medici e tra il 51% e il 100% degli infermieri coinvolti aveva somministrato almeno una volta nel corso della propria carriera un placebo “puro” (per esempio, un’iniezione di soluzione salina o pillole di zucchero), soprattutto per il trattamento dell’ansia, del dolore, dell’insonnia, di alcuni disturbi psicosomatici e dell’abuso di sostanze. Tuttavia, segnalano gli autori della ricerca, “sembra che la reale frequenza d’uso sia piuttosto rara”. Più diffuso, invece, potrebbe essere l’utilizzo di placebo “impuri” (per esempio, farmaci antibiotici utilizzati nel trattamento di malattie virali), ma questo fenomeno è più difficile da quantificare in quanto non esiste una definizione condivisa di questo tipo di interventi [1].
Come funziona l’effetto placebo?
 L’efficacia di un qualsiasi trattamento è influenzata dal contesto emotivo e psicosociale in cui questo viene somministrato. È questo il motivo, ad esempio, per cui molte persone reputano efficaci approcci terapeutici senza fondamento scientifico. I meccanismi attraverso cui può manifestarsi l’effetto placebo, tuttavia, sono variabili e legati alla situazione specifica.
L’efficacia di un qualsiasi trattamento è influenzata dal contesto emotivo e psicosociale in cui questo viene somministrato. È questo il motivo, ad esempio, per cui molte persone reputano efficaci approcci terapeutici senza fondamento scientifico. I meccanismi attraverso cui può manifestarsi l’effetto placebo, tuttavia, sono variabili e legati alla situazione specifica.
Uno degli ambiti più studiati riguarda la relazione tra placebo e dolore, dove un ruolo centrale sembra essere giocato dall’aspettativa stessa della riduzione del dolore: quando si assume un trattamento o ci si sottopone a una qualsiasi procedura medica per questa indicazione, infatti, la sola aspettativa della sua efficacia è in grado di attivare il rilascio di oppioidi endogeni (es. endorfine) nelle aree del cervello che controllano le sensazioni dolorose [2,3]. Infatti, se dopo la somministrazione di un placebo si procede con quella di una sostanza in grado di bloccare l’attività degli oppioidi endogeni, l’effetto placebo si riduce o scompare [4,5,6].
Ma funziona anche se si è consapevoli che si tratta di un placebo?
Uno dei problemi legati all’utilizzo di un placebo, e quindi di un trattamento che non ha un effetto fisiologico sulla malattia per cui viene assunto, è che questo presuppone di ingannare il paziente. Ovviamente, ciò comporta una serie di problemi etici: è giusto ingannare una persona anche se ne ottiene un beneficio? E se fosse contraria? Se questo tipo di comportamenti è da considerarsi legittimo, fino a dove ci si può spingere? Tuttavia, almeno nell’ambito di alcune patologie, come ad esempio la sindrome dell’intestino irritabile o la sindrome da deficit di attenzione e iperattività, questi dilemmi potrebbero essere risolti rendendo consapevoli i pazienti della reale natura del trattamento (utilizzo open label del placebo). Infatti, alcuni studi hanno dimostrato che in queste condizioni l’utilizzo di un placebo presentato come tale al paziente può essere comunque efficace [7]. Ma dal momento che gli studi che hanno indagato questo aspetto sono ancora di piccole dimensioni, saranno necessarie ulteriori ricerche per capire quanto questo effetto sia replicabile e utilizzabile in un contesto clinico [8].
Argomenti correlati:
AnsiaEffetto placeboFarmaciMedicinaliTerapie