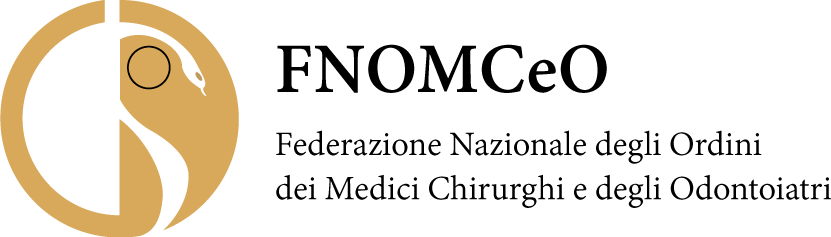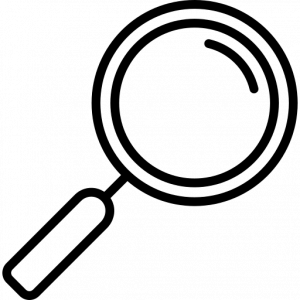L’antivirale paxlovid riduce il rischio di progressione dell’infezione da SARS-CoV-2 verso le forme più gravi di Covid-19, ma talvolta, dopo la fine del trattamento, la malattia sembra ripresentarsi, con i suoi sintomi tipici e con un test che, dopo essersi negativizzato, torna a essere positivo. All’inizio sembravano aneddoti raccontati qua e là da singoli medici e pazienti [1], ma ormai del fenomeno si comincia a parlare anche in ambito scientifico, sebbene per lo più con articoli usciti su piattaforme di preprint (quindi non ancora sottoposti alla revisione tra pari) [2,3].
L’antivirale paxlovid riduce il rischio di progressione dell’infezione da SARS-CoV-2 verso le forme più gravi di Covid-19, ma talvolta, dopo la fine del trattamento, la malattia sembra ripresentarsi, con i suoi sintomi tipici e con un test che, dopo essersi negativizzato, torna a essere positivo. All’inizio sembravano aneddoti raccontati qua e là da singoli medici e pazienti [1], ma ormai del fenomeno si comincia a parlare anche in ambito scientifico, sebbene per lo più con articoli usciti su piattaforme di preprint (quindi non ancora sottoposti alla revisione tra pari) [2,3].
A suggerire che la notizia sia degna di attenzione è soprattutto un avviso pubblico dei Centri per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CDC) del governo statunitense ad Atlanta, secondo cui questo “effetto rebound” si può verificare in alcuni individui anche se hanno difese immunitarie normali, dopo un’apparente prima risoluzione di Covid-19, indipendentemente dal fatto che siano stati trattati con paxlovid e che in precedenza fossero o no vaccinati, e avessero o no ricevuto un richiamo. Il ritorno di Covid-19 riguarda l’1-2% dei casi “guariti”, che abbiano ricevuto il farmaco o il placebo. Può comparire da 2 a 8 giorni dopo la guarigione iniziale ed è caratterizzato da una ripresa dei sintomi della malattia o soltanto da un nuovo test positivo, successivo a uno negativo [4].
Dottore, da cosa dipendono queste ricadute?
 Talvolta si è pensato che il primo tampone di guarigione che aveva decretato la fine dell’infezione fosse un falso negativo, un errore possibile con qualunque esame. Ma poiché spesso il paziente torna anche a stare male, non può trattarsi solo di un limite del test diagnostico. Deve essere il virus che effettivamente ricomincia a moltiplicarsi e ad attaccare l’organismo. I dati raccolti nei casi riportati negli articoli scientifici escludono che la ricaduta sia solo apparente e che il ritorno dei sintomi possa essere dovuto alla sovrapposizione di altre infezioni respiratorie comuni, a una reinfezione con SARS-CoV-2 o allo sviluppo di resistenza a paxlovid.
Talvolta si è pensato che il primo tampone di guarigione che aveva decretato la fine dell’infezione fosse un falso negativo, un errore possibile con qualunque esame. Ma poiché spesso il paziente torna anche a stare male, non può trattarsi solo di un limite del test diagnostico. Deve essere il virus che effettivamente ricomincia a moltiplicarsi e ad attaccare l’organismo. I dati raccolti nei casi riportati negli articoli scientifici escludono che la ricaduta sia solo apparente e che il ritorno dei sintomi possa essere dovuto alla sovrapposizione di altre infezioni respiratorie comuni, a una reinfezione con SARS-CoV-2 o allo sviluppo di resistenza a paxlovid.
Alcuni esperti hanno ipotizzato che, riducendo la carica virale, il farmaco diminuisca lo stimolo rivolto al sistema immunitario, che quindi non sarebbe attivato a sufficienza per eliminare del tutto l’infezione [5]. Una volta rimosso il freno posto dal medicinale, SARS-CoV-2 potrebbe quindi ricominciare a proliferare. Ma se queste ricadute avvenivano anche prima che si cominciasse a distribuire paxlovid ai pazienti più fragili, e avvengono ancora in persone giovani e sane che non lo prendono, si può dedurre che il farmaco non ne sia il solo né il principale responsabile. Anche nel corso degli studi iniziali eseguiti per ottenere l’autorizzazione di emergenza, la ripositivizzazione o l’aumento della carica virale al termine del trattamento sono stati riscontrati sia nel gruppo assegnato a paxlovid, sia tra chi assumeva il placebo [6].
Un’altra ipotesi è che, in maniera simile a quel che fanno altri virus, talvolta SARS-CoV-2 riesca a nascondersi dall’attacco del sistema immunitario e dell’antivirale in particolari organi e tessuti all’interno dell’organismo, e che in queste nicchie se ne stia al riparo fin quando il trattamento viene interrotto e davanti al via libera possa ricominciare a proliferare.
Dottore, ma in caso di ricaduta ci si deve preoccupare?
 La ripresa dei sintomi dopo l’apparente guarigione iniziale può essere una scocciatura, ma non deve destare preoccupazione. Secondo i CDC, in questi casi non sono state riferite forme gravi. Nella maggior parte dei casi il test torna a positivizzarsi in soggetti asintomatici. Quando ci sono, i disturbi sono sempre lievi e si risolvono da soli nel giro di pochi giorni.
La ripresa dei sintomi dopo l’apparente guarigione iniziale può essere una scocciatura, ma non deve destare preoccupazione. Secondo i CDC, in questi casi non sono state riferite forme gravi. Nella maggior parte dei casi il test torna a positivizzarsi in soggetti asintomatici. Quando ci sono, i disturbi sono sempre lievi e si risolvono da soli nel giro di pochi giorni.
L’unica precauzione da tenere presente è che il fenomeno potrebbe associarsi a un ritorno della contagiosità del paziente, che quindi deve tornare in isolamento e seguire di nuovo le indicazioni previste dalle autorità sanitarie per chi scopre di essere positivo.
Non sembra invece necessario intervenire con nuove cure, ricominciare a prendere l’antivirale, né raccomandare di prolungare a dieci giorni la durata del trattamento per prevenire l’insorgenza di questi ritorni dell’infezione. L’idea di un secondo corso di terapia per abbattere la recrudescenza dell’infezione è stata avanzata in un’intervista concessa a Bloomberg da Albert Bourla, amministratore delegato di Pfizer, l’azienda che produce il farmaco, autorizzato negli Stati Uniti come in Europa per un trattamento della durata di cinque giorni, pari a un costo di circa 500 euro, che secondo il manager si potrebbe ripetere. L’ipotesi è stata per ora decisamente respinta dalla Food and Drug Administration, con le parole del suo direttore per le malattie infettive, John Farley: “Stiamo continuando a rivedere i dati che arrivano dai trial clinici e forniremo ulteriori informazioni non appena saranno disponibili” ha dichiarato sul sito ufficiale dell’agenzia. “In ogni caso, a oggi non c’è nessuna prova che un trattamento più prolungato (per esempio a dieci giorni, invece dei cinque raccomandati nel foglietto illustrativo) oppure la ripetizione di un secondo ciclo di paxlovid in pazienti in cui sintomi di Covid-19 tornano dopo la fine del trattamento possano offrire benefici” [6].
Questi dati non mettono in dubbio i vantaggi della cura nei soggetti ad alto rischio di progressione, in cui il ciclo di cinque giorni sembra ridurre di quasi il 90% il rischio di ricovero e morte [7]. Il dibattito riguarda solo l’eventuale prolungamento o ripetizione della terapia, che potrebbe essere autorizzato in futuro soltanto nel caso in cui emergessero benefici sufficienti a controbilanciare i rischi legati al trattamento con l’antivirale, soprattutto nei pazienti con un’insufficienza renale anche lieve.
Argomenti correlati:
CoronavirusMedicina