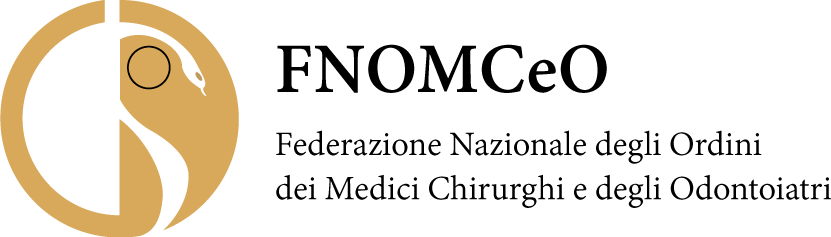Possedere alcuni geni rimasti alla nostra specie Homo sapiens dall’incontro con i Neanderthal, avvenuto circa 100.000 anni fa, potrebbe renderci più suscettibili a Covid-19. Ma questa eventuale predisposizione genetica è solo uno dei fattori che influiscono sull’andamento della malattia. E, soprattutto, non abbiamo a oggi nessuna prova che nel DNA degli abitanti nella provincia di Bergamo – duramente colpita nella prima ondata – le varianti genetiche di cui si parla siano più frequenti che altrove.
Possedere alcuni geni rimasti alla nostra specie Homo sapiens dall’incontro con i Neanderthal, avvenuto circa 100.000 anni fa, potrebbe renderci più suscettibili a Covid-19. Ma questa eventuale predisposizione genetica è solo uno dei fattori che influiscono sull’andamento della malattia. E, soprattutto, non abbiamo a oggi nessuna prova che nel DNA degli abitanti nella provincia di Bergamo – duramente colpita nella prima ondata – le varianti genetiche di cui si parla siano più frequenti che altrove.
La scoperta del possibile ruolo dei “geni di Neanderthal”, come sono stati ribattezzati, risale ai primi mesi della pandemia. Ben presto fu evidente infatti che, tra i fattori di rischio per Covid-19 capaci di fare la differenza tra un banale raffreddore e un’infezione mortale, non c’erano solo l’età, il genere o la presenza di altre malattie o condizioni predisponenti (come diabete, obesità, o compromissione – per varie ragioni – delle difese immunitarie).
Il primo caso riconosciuto in Italia, sopravvissuto dopo un lungo e difficile ricovero, era un giovane sportivo, mentre, al contrario, non sono pochi i grandi anziani fragili che hanno superato l’infezione senza quasi accorgersene. L’ipotesi che anche una predisposizione genetica potesse giocare un ruolo sembrava inoltre suffragata dal fatto che spesso le forme più gravi della malattia si osservavano nei membri dello stesso nucleo familiari.
Dottore, ma come si è arrivati a questa conclusione?
 Già nel 2020, quindi, una serie di studi ha messo a confronto il patrimonio genetico di migliaia di persone con Covid-19 in forma grave con quello di individui sani, per verificare se, tra le normali varianti genetiche presenti nel DNA, alcune fossero più frequenti in questi soggetti che nella popolazione generale. I loro risultati attirarono per esempio l’attenzione degli scienziati sulla regione del genoma che determina i gruppi sanguigni AB0: essere di gruppo A sembrava andare di pari passo con un rischio aumentato di Covid grave, mentre il gruppo 0 risultava associato a un effetto protettivo [1]. Studi successivi, però, non hanno riprodotto in maniera costante questo risultato, su cui oggi restano dubbi [2,3].
Già nel 2020, quindi, una serie di studi ha messo a confronto il patrimonio genetico di migliaia di persone con Covid-19 in forma grave con quello di individui sani, per verificare se, tra le normali varianti genetiche presenti nel DNA, alcune fossero più frequenti in questi soggetti che nella popolazione generale. I loro risultati attirarono per esempio l’attenzione degli scienziati sulla regione del genoma che determina i gruppi sanguigni AB0: essere di gruppo A sembrava andare di pari passo con un rischio aumentato di Covid grave, mentre il gruppo 0 risultava associato a un effetto protettivo [1]. Studi successivi, però, non hanno riprodotto in maniera costante questo risultato, su cui oggi restano dubbi [2,3].
Il metodo utilizzato per questo tipo di ricerche, dette GWAS (“genome-wide association studies)”, infatti, non permette di individuare direttamente il gene responsabile di una malattia o della sua gravità, ma si limita a indicare ai ricercatori l’area del genoma dove si osservano nei malati più spesso che nei sani certe sequenze di DNA [4]. Maggiore è il numero di genomi esaminati, minore è il rischio di incappare in un’associazione casuale, per cui, in genere, questo tipo di ricerche è condotto su enormi database di decine o centinaia di migliaia, quando non milioni, di persone.
Studi di questa ampiezza negli ultimi tre anni hanno permesso di individuare a oggi una cinquantina di punti critici del DNA correlati alla suscettibilità a SARS-CoV-2 [5,6].
Quelli “ereditati” dai Neanderthal sono solo una minima parte di questi, per quanto l’idea di questo legame con un tempo così lontano possa stuzzicare la nostra curiosità più delle criptiche sigle composte da numeri e lettere che definiscono tutti gli altri.
Dottore, ma che cosa c’entra Neanderthal?
Già nel 2020, il genetista svedese Svante Pääbo, insieme al suo allievo Hugo Zeberga, aveva scoperto che una delle lunghe sequenze di DNA presenti sul cromosoma 3 e associate a forme più gravi di Covid-19 è molto simile a quella dei resti di un Neanderthal ritrovati in Croazia, meno con quelli di uno proveniente dalla Siberia. Lo scienziato, che due anni dopo avrebbe vinto il premio Nobel, ha dimostrato che questa sequenza è arrivata a noi nel corso degli scambi avvenuti tra le due specie nel Paleolitico, quando i nostri progenitori, dopo aver lasciato l’Africa, incontrarono la popolazione dei “cugini” che già occupavano l’Europa e il Medio Oriente, mentre un’altra specie, detta dei Denisoviani, colonizzava l’Asia.
I geni provenienti dai Neanderthal, compresi quelli che aumentano il rischio di Covid-19 grave, sono quindi praticamente assenti nella popolazione africana, che non è mai venuta a contatto con loro, se non occasionalmente, in fasi tardive, e in zone periferiche. L’assetto genetico che aumenta il rischio di forme gravi di Covid-19 è invece molto frequente nell’Asia meridionale. Qui circa la metà delle persone ne possiede almeno una copia, ma il record si registra in Bangladesh, il 60% della popolazione è portatore di almeno una copia e il 13% degli individui è omozigote, cioè possiede “i geni di Neanderthal” su entrambi i cromosomi 3 presenti in ogni cellula, sia quello proveniente dal padre, sia quello proveniente dalla madre.
Stranamente si osserva invece una situazione opposta nell’Estremo Oriente, dove questa predisposizione genetica è molto rara. È possibile che le due parti dell’Asia abbiano subito nel tempo l’azione di diversi fattori selettivi, per esempio per l’importanza maggiore o minore di altre malattie nei confronti delle quali queste varianti genetiche rappresentavano un fattore predisponente o, viceversa, protettivo.
Tornando in Europa, i portatori delle sequenze a rischio per forme gravi di Covid-19 da noi sono circa il 13%, mentre negli Stati Uniti, con il suo “melting pot” genetico di origini diverse, non si raggiunge il 10%. Gli altissimi tassi di mortalità osservati in questo Paese nonostante ciò, soprattutto nelle persone di discendenza africana che non possiedono affatto i “geni di Neanderthal”, dimostrano che il fattore genetico, pur esistente, non è certo l’unico, né il più importante [7].
Dottore, ma cosa dice lo studio fatto a Bergamo?
 Recentemente, uno studio condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo ha confermato il legame tra forme gravi di Covid-19 e particolari regioni genetiche del cromosoma 3, individuando anche nuovi possibili punti del DNA che potrebbero essere coinvolti nella suscettibilità all’infezione o nella risposta individuale alla malattia [8].
Recentemente, uno studio condotto dall’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Bergamo ha confermato il legame tra forme gravi di Covid-19 e particolari regioni genetiche del cromosoma 3, individuando anche nuovi possibili punti del DNA che potrebbero essere coinvolti nella suscettibilità all’infezione o nella risposta individuale alla malattia [8].
Dopo la prima ondata pandemica hanno infatti scelto volontariamente di rispondere a un questionario online quasi 10.000 abitanti della provincia di Bergamo, circa la metà dei quali riferiva di aver avuto sintomi compatibili con Covid-19 nei mesi precedenti. Di questi, alla fine solo 1.100 circa sono stati inclusi nello studio vero e proprio, chiamato ORIGIN, che ha confermato anche in questa popolazione l’associazione, già dimostrata in precedenza, tra la presenza di un particolare sequenza sul cromosoma 3 (3p21.31 locus) e la gravità della malattia.
Rispetto agli studi condotti su grandi numeri in tutto il mondo (per esempio la Covid-19 Host Genetic Initiative, HGI, che ha studiato un centinaio di popolazioni diverse provenienti da una dozzina di paesi), la ricerca condotta a Bergamo ha trovato che la sequenza ha inciso più di quanto osservato altrove sul rischio di malattia grave. Forse anche perché il minor numero di partecipanti ha consentito ai ricercatori di verificare nei dettagli i dati clinici e con colloqui personali quelli raccolti col questionario, così da poter accoppiare meglio casi e controlli per età, sesso, altre malattie. Il campione inoltre era omogeneo per abitudini e cultura ed esposto massivamente allo stesso virus, prima che insorgessero varianti e si introducessero terapie e vaccini. In tal modo le differenze dovute ai geni emergono più chiaramente.
Tuttavia, pur rappresentando una stimolante ipotesi di ricerca, i risultati di questo lavoro non sembrano in alcun modo suggerire che nella provincia di Bergamo l’assetto genetico proveniente dai Neanderthal sia più frequente che altrove, né tanto meno che ciò possa spiegare l’altissima mortalità registrata in questa zona, tra le prime in Occidente a essere colpite con violenza dai contagi nella primavera del 2020.
Argomenti correlati:
Coronavirus