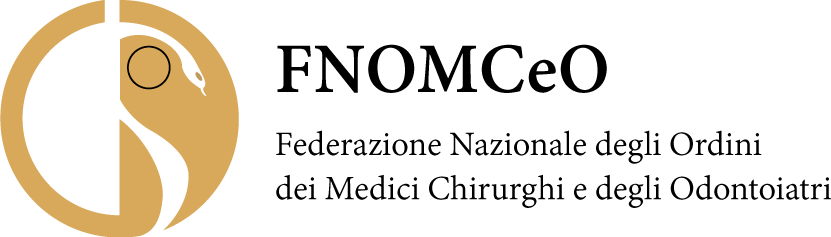Per molte malattie, una diagnosi precoce è fondamentale: riconoscere prontamente la causa di uno o più sintomi permette di ottenere risultati migliori dalle cure, e talvolta una completa guarigione [1]. I programmi di screening puntano ad anticipare questo processo, cercando di scovare condizioni patologiche che ancora non si sono manifestate in persone apparentemente sane e senza particolari disturbi [2]. In questo modo, tuttavia, è possibile anche rilevare formazioni o anomalie che, qualora fossero passate inosservate, non avrebbero influito sulla qualità o l’aspettativa di vita di quell’individuo. Si parla in questi casi di “sovradiagnosi” [3-5].
Per molte malattie, una diagnosi precoce è fondamentale: riconoscere prontamente la causa di uno o più sintomi permette di ottenere risultati migliori dalle cure, e talvolta una completa guarigione [1]. I programmi di screening puntano ad anticipare questo processo, cercando di scovare condizioni patologiche che ancora non si sono manifestate in persone apparentemente sane e senza particolari disturbi [2]. In questo modo, tuttavia, è possibile anche rilevare formazioni o anomalie che, qualora fossero passate inosservate, non avrebbero influito sulla qualità o l’aspettativa di vita di quell’individuo. Si parla in questi casi di “sovradiagnosi” [3-5].
Il concetto di sovradiagnosi non si riferisce a referti “falsi positivi”, cioè a diagnosi iniziali poi smentite da ulteriori accertamenti. I tumori (o altre malattie) “sovradiagnosticati” sono indistinguibili nel singolo caso da formazioni analoghe individuate in pazienti simili. In altre parole, quando una malattia viene scoperta per caso, o nel corso di un check-up, non è possibile sapere se questo sia un colpo di fortuna che salverà la vita.
Spesso è così, ma in una minore percentuale di casi significherà affrontare il peso della diagnosi e dei trattamenti senza trarne vantaggio. Le cure, infatti, possono risultare inutili se non influiscono sulla qualità di vita o la sopravvivenza dell’individuo. Ciò si può verificare per esempio nel caso in cui la malattia sarebbe rimasta silente, cioè non avrebbe mai dato segno di sé, oppure nel caso in cui l’individuo è destinato a morire per altre cause prima che questa cominci a manifestarsi. Nella maggior parte dei casi, al momento della diagnosi, questa evoluzione futura non si può affermare con certezza. Di “sovradiagnosi” si può parlare solo a posteriori e su grandi casistiche, quando si osserva che un aumento delle diagnosi precoci in una popolazione o in un ampio gruppo di persone non serve a ridurne la mortalità.
Dottore, può farmi qualche esempio?
Esistono tumori che non sappiamo di avere perché non ci provocano disturbi, e che non andranno a influire sulla nostra aspettativa e qualità di vita. Si può trattare di formazioni piccolissime che il sistema immunitario può ancora riuscire a eliminare da solo, oppure che per loro natura hanno una evoluzione e una crescita molto lente. Si chiamano “tumori indolenti”, e ci possono mettere anche decine di anni prima di manifestarsi. Se una persona ha già un’età avanzata (o altre malattie che riducono la sua aspettativa di vita), potrebbe non scoprire mai di esserne portatrice.
Si dice per esempio che siano molti di più gli uomini che alla fine della loro vita hanno un cancro alla prostata di quelli che muoiono a causa di questo stesso tumore. In media, infatti, considerando tutte le fasce di età, in un’autopsia maschile su cinque si trova un tumore della prostata passato inosservato durante la vita. Questa probabilità arriva alla metà dei casi negli ultranovantenni, in cui è maggiore anche la quota di tumori più aggressivi che non hanno avuto modo di manifestarsi proprio per l’insorgenza di altri eventi letali, più comuni tra gli anziani [6,7].
Lo stesso vale per alcuni tumori della tiroide, un tempo considerati rari e oggi molto comuni. Anche in questo caso, è stata dimostrata la presenza di piccoli noduli tumorali nella tiroide del 10-15% circa di persone decedute per altre cause. Un tempo queste formazioni passavano inosservate perché così piccole da non poter essere sentite dal medico con la semplice palpazione del collo. Oggi invece si trovano facilmente grazie a strumenti diagnostici molto sensibili come l’ecografia, la risonanza magnetica e la tomografia computerizzata [8,9].
Ciò permette di salvare i pazienti in cui la malattia si sarebbe manifestata in una fase più avanzata, ma al costo di trattare anche quelli il cui nodulo sarebbe rimasto silente per tutta la vita: tutti si sentiranno sollevati dalla diagnosi precoce, ma solo i primi ne trarranno un effettivo vantaggio.
In Italia è stato calcolato che tra la fine del secolo scorso e il 2012 l’aumento dei nuovi casi di tumore della tiroide è dipeso quasi esclusivamente da questo fenomeno, soprattutto nelle donne sotto i 55 anni [10].
Dottore, ma quali sono le conseguenze della sovradiagnosi?
 Gli svantaggi conseguenti alla sovradiagnosi sono molti, e di varia natura. Prima di tutto, ci sono le conseguenze dei trattamenti chirurgici e farmacologici, ciascuno dei quali porta con sé effetti indesiderati e rischi di complicazioni. Nel caso in cui la condizione scoperta per caso non avrebbe mai apportato danni al paziente, gli svantaggi associati alle cure non sono controbilanciati da alcun vantaggio. Si parla in questo caso di “sovratrattamento”.
Gli svantaggi conseguenti alla sovradiagnosi sono molti, e di varia natura. Prima di tutto, ci sono le conseguenze dei trattamenti chirurgici e farmacologici, ciascuno dei quali porta con sé effetti indesiderati e rischi di complicazioni. Nel caso in cui la condizione scoperta per caso non avrebbe mai apportato danni al paziente, gli svantaggi associati alle cure non sono controbilanciati da alcun vantaggio. Si parla in questo caso di “sovratrattamento”.
Accedere alle terapie può richiedere inoltre sacrifici personali o professionali e talvolta può avere anche un grave impatto sul proprio benessere economico, qualora il lavoratore non sia tutelato o laddove non esista o non sia efficiente un servizio sanitario pubblico universale. Non si può infine sottovalutare l’impatto psicologico ed esistenziale di una diagnosi, oncologica o no, che può favorire l’insorgenza di ansia e depressione e in ogni caso influisce sulla qualità di vita e le scelte di un individuo che fino a quel momento si credeva sano.
Dottore, ma come si evita la sovradiagnosi?
 Evitare del tutto la sovradiagnosi non è possibile, ma molto si può fare per ridurne la frequenza. Prima di tutto, studiando nuovi indicatori che permettano di prevedere l’evoluzione futura di una malattia scoperta fortuitamente. Già oggi, alcune caratteristiche come la localizzazione, la dimensione o il tipo istologico di un tumore consentono talvolta ai medici di calcolarne il rischio. Sono state così individuate circostanze – in relazione al tipo di malattia o di paziente – che consentono di adottare un atteggiamento di vigile attesa, con controlli periodici che permettano di intervenire tempestivamente solo qualora si manifesti un’accelerazione della crescita. In tal modo si possono evitare le conseguenze negative del trattamento qualora non sia strettamente necessario, senza rischiare di vanificare i vantaggi di una diagnosi precoce. Purtroppo, però, questa strada non è sempre possibile o prudente.
Evitare del tutto la sovradiagnosi non è possibile, ma molto si può fare per ridurne la frequenza. Prima di tutto, studiando nuovi indicatori che permettano di prevedere l’evoluzione futura di una malattia scoperta fortuitamente. Già oggi, alcune caratteristiche come la localizzazione, la dimensione o il tipo istologico di un tumore consentono talvolta ai medici di calcolarne il rischio. Sono state così individuate circostanze – in relazione al tipo di malattia o di paziente – che consentono di adottare un atteggiamento di vigile attesa, con controlli periodici che permettano di intervenire tempestivamente solo qualora si manifesti un’accelerazione della crescita. In tal modo si possono evitare le conseguenze negative del trattamento qualora non sia strettamente necessario, senza rischiare di vanificare i vantaggi di una diagnosi precoce. Purtroppo, però, questa strada non è sempre possibile o prudente.
Un altro modo di contrastare il fenomeno della sovradiagnosi consiste nell’attenersi ai programmi di screening organizzati dal Servizio sanitario nazionale. Questi, infatti, sono proposti solo nelle fasce di età e con la frequenza di controlli che hanno dimostrato di poter salvare più vite riducendo nel contempo al minimo il numero di persone che subiranno solo le conseguenze negative della diagnosi. La variabilità che a volte si osserva nelle raccomandazioni di diverse società scientifiche non dipende quindi solo dal costo economico dell’estensione di un programma di screening, ma anche dal peso che si attribuisce a ciascuno dei due fattori: la possibilità di salvare una vita in più grazie alla diagnosi precoce o il numero di vite condizionate da una diagnosi “inutile”.
Per esempio, ripetere la mammografia ogni due anni tra i 50 e i 69 anni permette di ridurre la mortalità per tumore al seno con un numero di sovradiagnosi inferiore a quelle che si registrano allargando lo screening a donne più giovani o più anziane, o con controlli più frequenti.
Di tutto questo non tengono invece conto i cosiddetti “pacchetti prevenzione” offerti dai centri diagnostici privati o altri esami eseguiti privatamente senza la prescrizione del medico, che aumentano al contrario il rischio di sovradiagnosi.
Argomenti correlati:
DiagnosiEsami diagnosticiMedicinaPrevenzione