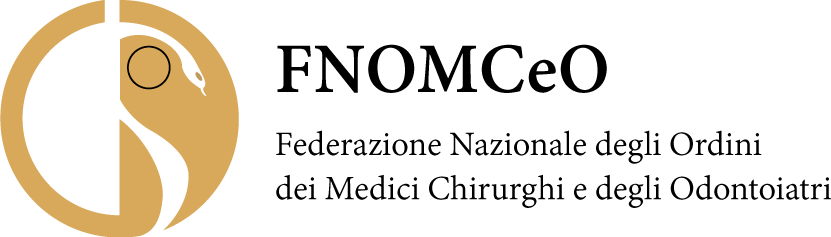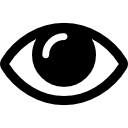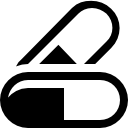Da dove nasce questa idea?
 Negli ultimi decenni si è diffuso il giusto principio che “prevenire sia meglio che curare”. Le persone sono più consapevoli dei comportamenti che possono adottare nella loro vita quotidiana per cercare di evitare diverse malattie, infettive o no, dall’influenza al cancro: sanno che conviene mangiare sano, svolgere una regolare attività fisica, ridurre l’alcol, evitare di fumare, dormire bene e sottoporsi alle vaccinazioni raccomandate per la loro condizione e la loro fascia di età. Tutti questi fattori contribuiscono a quella che si chiama “prevenzione primaria”, che serve a ridurre il rischio di sviluppare una o più malattie. È quindi un tentativo di prevenire che compaiano, ed è quindi anche l’unica vera “prevenzione” in senso stretto.
Negli ultimi decenni si è diffuso il giusto principio che “prevenire sia meglio che curare”. Le persone sono più consapevoli dei comportamenti che possono adottare nella loro vita quotidiana per cercare di evitare diverse malattie, infettive o no, dall’influenza al cancro: sanno che conviene mangiare sano, svolgere una regolare attività fisica, ridurre l’alcol, evitare di fumare, dormire bene e sottoporsi alle vaccinazioni raccomandate per la loro condizione e la loro fascia di età. Tutti questi fattori contribuiscono a quella che si chiama “prevenzione primaria”, che serve a ridurre il rischio di sviluppare una o più malattie. È quindi un tentativo di prevenire che compaiano, ed è quindi anche l’unica vera “prevenzione” in senso stretto.
A questa si affianca la cosiddetta “prevenzione secondaria”, che non consiste nell’impedire l’insorgenza di una condizione patologica, ma di individuarla in una fase sufficientemente precoce da poterla trattare in maniera efficace, con il miglior esito possibile e con il minor carico di conseguenze.
A questo scopo si effettuano i programmi nazionali di screening (come quello per il tumore dell’utero, del colon-retto e della mammella): non per prevenire la malattia nel senso di impedirla, ma per coglierla in una fase iniziale.
Tra i due tipi di prevenzione spesso si fa confusione, tanto che molte donne sono convinte che sottoporsi alla mammografia possa “prevenire” il tumore al seno, mentre invece si tratta di diagnosticarlo, se c’è, quando è ancora piccolo e localizzato.
Per analogia con questi esami, raccomandati a età e cadenze precise allo scopo di ridurre la mortalità per alcune particolari malattie, ci si è però convinti che una diagnosi precoce sia sempre e comunque da preferire e che, di conseguenza, ci si debba sottoporre al maggior numero di esami possibile per intercettare ogni eventuale anomalia. “Meglio un accertamento in più che uno in meno”, pensano in molti.
Molti centri medici privati offrono quindi “pacchetti prevenzione” costituiti da varie combinazioni di indagini, che pubblicizzano a persone che stanno bene e sono senza sintomi. Molte aziende, dal canto loro, forniscono ai dipendenti check-up annuali più o meno ricchi di accertamenti. Chi non può usufruire di questi benefit spesso chiede allora al medico di famiglia di potersi sottoporre a queste indagini “alla cieca”. Quando poi trovano resistenze da parte del curante, i cittadini finiscono per attribuirle solo ai controlli sull’eccesso di spesa a cui è sottoposto, e non a una scelta fatta in funzione della sua salute.
È facile pensare che chi consiglia di sottoporsi solo agli esami necessari lo faccia per ragioni economiche di risparmio, e ciò crea in chi li chiede un senso di frustrazione, come se fosse privato di opportunità di cui chi si trova con maggiore disponibilità economica, invece, può comunque permettersi di usufruire attraverso la sanità privata.
Che cosa la smentisce?
 Al crescere delle capacità diagnostiche offerte da nuove metodiche e tecnologie siamo destinati a scoprire che nessuno è del tutto sano. Se non una vera e propria malattia, tutti possiamo avere una transitoria alterazione di qualche parametro o almeno una predisposizione a svilupparla in futuro.
Al crescere delle capacità diagnostiche offerte da nuove metodiche e tecnologie siamo destinati a scoprire che nessuno è del tutto sano. Se non una vera e propria malattia, tutti possiamo avere una transitoria alterazione di qualche parametro o almeno una predisposizione a svilupparla in futuro.
I programmi nazionali di screening, che consigliano esami periodici a persone apparentemente sane e senza nessun disturbo, sono basati su valutazioni molto complesse: a parte i criteri di sostenibilità – per cui l’esame deve essere sufficientemente a buon mercato –, semplicità di esecuzione e accettabilità da parte del cittadino, occorre che il test abbia un’alta sensibilità (cioè una buona capacità di individuare ogni segnale sospetto) e specificità (sia in grado cioè di riconoscere le anomalie preoccupanti da quelle che non lo sono). In questo modo si riducono al minimo i falsi negativi (che potrebbero portare le persone a sentirsi falsamente rassicurate dal controllo appena eseguito, col rischio di sottovalutare successivi sintomi) e i falsi positivi (che creano inutilmente ansia e comportano disagio, costi e rischi supplementari per l’esecuzione di ulteriori indagini di conferma o smentita).
È indispensabile inoltre che la malattia da andare a cercare sia abbastanza frequente, nella popolazione da sottoporre all’esame, che il programma non si trasformi nella ricerca di un ago in un pagliaio e soprattutto che, una volta scovata, sia disponibile un provvedimento terapeutico capace di guarirla o cambiarne in maniera significativa il decorso.
Soddisfatte tutte queste richieste, è importante che un programma di screening dimostri, nel giro di un certo numero di anni dalla sua implementazione, di poter ridurre la mortalità per la condizione che va a cercare. Se invece ne aumenta solo la frequenza, individuando un maggior numero di casi ma senza produrre un miglioramento nella mortalità per quella specifica malattia, significa che la diagnosi è stata solo anticipata. Ciò ha sottratto mesi o anni di vita in salute al paziente, che ha saputo prima di essere ammalato, ma che per questo non ha avuto salva né allungata la vita. Oppure si è verificato il fenomeno della “sovradiagnosi”, con il riconoscimento e la cura di malattie che non avrebbero mai messo in pericolo la vita del paziente, che è stato invece sottoposto agli effetti collaterali di trattamenti inutili.
Al di fuori dei programmi raccomandati, questi rischi crescono. Nessun esame è infallibile, esistono margini di errore, variabilità individuali, artefatti di varia natura per cui indagini condotte a tappeto, alla vaga ricerca di “qualcosa che non va” invece che per rispondere a un preciso quesito diagnostico, non sono solo uno spreco di denaro privato o pubblico che sottrae risorse a qualcosa di più utile o indispensabile, ma possono anche provocare danni alla salute.
Per esempio i tumori scoperti per caso, nel corso di altri accertamenti, sono detti “incidentalomi”: spesso sono localizzati a livello dei surreni, ma possono essere noduli trovati per caso anche a livello del rene, della tiroide, del polmone o di altri organi.
Una volta accertata un’anomalia è dovere del medico accertare che non sia segno di una malattia, e ciò può provocare una serie di ulteriori accertamenti, alcuni dei quali invasivi e non scevri da rischi. Tutto ciò può creare al paziente più problemi di quanto non avrebbe fatto l’eventuale nodulo silente, nel caso degli incidentalomi, o la leggera alterazione di un valore nell’esame del sangue, magari segno di una variabilità individuale.
Che cosa si è fatto?
 Per questo dagli Stati Uniti è partita un’iniziativa chiamata Choosing wisely, che si è estesa a molti Paesi, tra cui l’Italia, per favorire il dialogo tra medico e paziente al fine di individuare indagini e trattamenti sostenuti da prove scientifiche che non duplichino altri test o procedure già effettuate, che non facciano danni e che siano realmente necessari.
Per questo dagli Stati Uniti è partita un’iniziativa chiamata Choosing wisely, che si è estesa a molti Paesi, tra cui l’Italia, per favorire il dialogo tra medico e paziente al fine di individuare indagini e trattamenti sostenuti da prove scientifiche che non duplichino altri test o procedure già effettuate, che non facciano danni e che siano realmente necessari.
A partire dal 2012 le Società scientifiche e le Associazioni professionali statunitensi hanno cominciato a chiedere ai loro membri di identificare gli esami o le procedure usate comunemente nel loro settore la cui necessità dovesse essere messa in discussione.
Nel nostro Paese l’iniziativa ha preso il nome di Choosing Wisely Italy, con il claim “Fare di più non significa fare meglio”. Sul suo sito si può trovare una lista di pratiche che in Italia sono considerate a rischio di inappropriatezza – fornite da un lungo elenco di associazioni e società scientifiche – di cui medici, altri professionisti, pazienti e cittadini devono parlare prima della prescrizione.
Il punto infatti non è non fare esami, né tantomeno mettere la testa nella sabbia davanti a un possibile problema, ma sottoporsi solo agli accertamenti che il medico ritiene necessari per un determinato paziente, alla luce della sua condizione e di eventuali disturbi.
Argomenti correlati:
Esami diagnosticiMedicinaPrevenzioneRisonanza magnetica