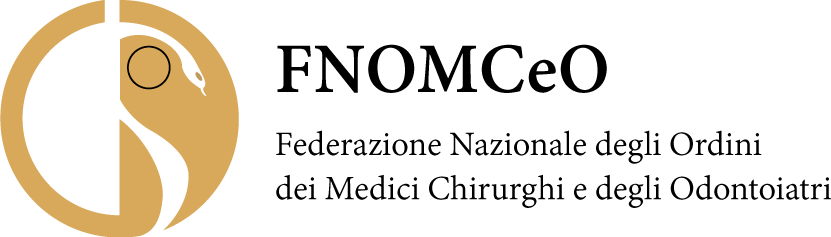Il prediabete è una condizione caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue e insulina circolante che, pur essendo superiori alla norma, non risultano abbastanza elevati da essere ritenuti indicativi della presenza di un diabete di tipo 2. Una condizione che, secondo l’Associazione dei diabetologi americani (American Diabetes Association), rappresenta però un fattore di rischio per il successivo sviluppo di un diabete di tipo 2 e che richiede quindi un trattamento preventivo.
Il prediabete è una condizione caratterizzata da livelli di glucosio nel sangue e insulina circolante che, pur essendo superiori alla norma, non risultano abbastanza elevati da essere ritenuti indicativi della presenza di un diabete di tipo 2. Una condizione che, secondo l’Associazione dei diabetologi americani (American Diabetes Association), rappresenta però un fattore di rischio per il successivo sviluppo di un diabete di tipo 2 e che richiede quindi un trattamento preventivo.
Una presa di posizione, questa, sancita dalla scelta da parte dell’ADA di abbassare la soglia del test che definisce la diagnosi di prediabete e che di fatto amplia la platea dei pazienti trattabili. Tuttavia, le evidenze che dimostrano un collegamento tra prediabete e diabete sono spesso caratterizzate da scarsa qualità e difetti metodologici. Inoltre, secondo un’inchiesta realizzata dalla rivista Science, la scelta dell’ADA potrebbe essere stata guidata da conflitti di interesse [1].
Da dove nasce il concetto di prediabete?
Nel 2001 l’allora capo delle relazioni esterne dell’ADA contattò Richard Kahn, all’epoca direttore scientifico dell’associazione, per chiedergli di aiutarlo a convincere medici e pazienti della pericolosità di un innalzamento dei livelli di glucosio nel sangue in termini di probabilità di sviluppare, successivamente, un diabete di tipo 2. Così, dopo aver radunato gli esperti dell’ADA e in accordo con Ann Albright, responsabile dell’unità di prevenzione del diabete dei Centers for Disease Control and Prevention (CDCs), Kahn e gli altri vertici decisero di denominare i casi di innalzamento dei livelli di glucosio come “prediabete”, termine scelto proprio per esplicitare il collegamento con il diabete e quindi con il rischio di amputazioni, cecità e attacchi di cuore. Decisero poi di dichiarare guerra al prediabete, sostenendo che una percentuale compresa tra il 15% e il 30% delle persone incluse in questa categoria diagnostica, se non trattata adeguatamente, progredisce verso un diabete di tipo 2.
Chi viene considerato prediabetico?
 L’attuale definizione di prediabete risale al 2009, quando l’ADA, insieme alla European Association for the Study of Diabetes (EASD) e all’International Diabetes Federation (IDF), decise di convocare una commissione di esperti per valutare le evidenze relative a un test che misura i livelli di emoglobina glicata nel sangue, indicativi dei livelli medi di glucosio dei tre mesi precedenti.
L’attuale definizione di prediabete risale al 2009, quando l’ADA, insieme alla European Association for the Study of Diabetes (EASD) e all’International Diabetes Federation (IDF), decise di convocare una commissione di esperti per valutare le evidenze relative a un test che misura i livelli di emoglobina glicata nel sangue, indicativi dei livelli medi di glucosio dei tre mesi precedenti.
La commissione in questione stabilì che valori pari o superiori al 6% dovevano essere presi in considerazione per interventi preventivi. Tuttavia, rifiutò la definizione di “prediabete”, sostenendo la mancanza di un nesso certo tra prediabete e diabete. Ciononostante, l’ADA si mosse in direzione contraria: abbassò il livello soglia da 6,1% a 5,7% e stabilì un collegamento chiaro tra le due condizioni. Solo con questa mossa, il numero di cittadini statunitensi potenzialmente trattabili per un prediabete aumentò di circa 72 milioni di unità.
Ma il prediabete evolve sempre in diabete?
La questione è stata affrontata in un recente studio della Cochrane, in cui sono stati aggregati i dati provenienti da 104 ricerche sul tema per un totale di oltre 250.000 soggetti considerati. Dai risultati è emerso che, in genere, la probabilità di sviluppare il diabete di tipo 2 a partire da una condizione di prediabete aumentava col tempo.
Tuttavia, nel corso dello studio molti dei soggetti considerati prediabetici sono tornati ai livelli normali di glucosio nel sangue. Anche se rispetto alle persone con livelli nella norma quelli con prediabete sono risultati associati a un aumentato rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, i risultati – sottolineano gli autori della ricerca – mostrano ampie differenze legate ai metodi di rilevazione e misurazione del prediabete [2].
Al contrario, per giustificare la necessità di trattamenti aggressivi i rappresentanti di ADA e i CDCs citano spesso i risultati dello studio DPPOS (Diabetes Prevention Program Outcomes Study), il quale aveva messo in evidenza un tasso ridotto di passaggi da prediabete a diabete in un gruppo di pazienti sottoposto a interventi preventivi rispetto al gruppo di controllo [3]. Tuttavia, anche in questo caso, alcuni ricercatori hanno messo in evidenza le limitazioni metodologiche dello studio e criticato le interpretazioni degli autori [1].
È possibile che ci siano degli interessi economici di mezzo?
 La definizione di prediabete ha innescato dei cambiamenti importanti nel panorama medico statunitense: il budget dei CDCs dedicato alla prevenzione del diabete, ad esempio, è passato dai 66 milioni di dollari del 2010 ai 173 del 2017. Inoltre, secondo ClinicalTrials.gov, negli Stati Uniti ci sono attualmente più di 100 tra farmaci e supplementi in fase di sperimentazione per il trattamento preventivo del diabete. Molte aziende hanno poi fatto pressioni sulla Food and Drug Administration (FDA) per ottenere l’approvazione per altri integratori alimentari e rimedi vari destinati ai prediabetici.
La definizione di prediabete ha innescato dei cambiamenti importanti nel panorama medico statunitense: il budget dei CDCs dedicato alla prevenzione del diabete, ad esempio, è passato dai 66 milioni di dollari del 2010 ai 173 del 2017. Inoltre, secondo ClinicalTrials.gov, negli Stati Uniti ci sono attualmente più di 100 tra farmaci e supplementi in fase di sperimentazione per il trattamento preventivo del diabete. Molte aziende hanno poi fatto pressioni sulla Food and Drug Administration (FDA) per ottenere l’approvazione per altri integratori alimentari e rimedi vari destinati ai prediabetici.
Infine, secondo l’inchiesta di Science almeno 7 dei 14 esperti che hanno lavorato alle linee guida ADA – le quali raccomandano di trattare i prediabetici – avrebbero ricevuto, tra il 2013 e il 2017, somme comprese tra i 41.000 e i 6,8 milioni di dollari da parte di industrie produttrici di farmaci in fase di sperimentazione per questa condizione. Il sospetto, dunque, c’è.
John Ioannidis, esperto di evidence-based medicine della Stanford University di Palo Alto (California), ha così commentato la scelta dell’ADA: “Abbiamo una combinazione di due forze. Da una parte si amplia la definizione della malattia in modo da poter classificare più persone come malate e bisognose di un trattamento, dall’altra si supportano interventi per cui [gli autori delle linee guida] presentano dei conflitti di interesse”.
Argomenti correlati:
DiabeteMedicinaPrevenzione