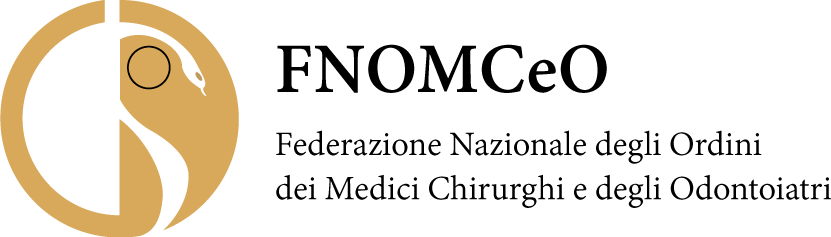La “notizia” è nata da un documento prodotto dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) che parte da una premessa: “il particolato atmosferico (PM10, PM2.5) costituisce un efficace vettore per il trasporto, la diffusione e la proliferazione delle infezioni virali” [1]. Come affermano i firmatari di questo position paper (una sorta di documento consensuale al quale un’associazione giunge dopo un confronto interno, che dovrebbe essere il più possibile trasparente), si tratta di una “deduzione” basata su una “sintetica introduzione e rassegna scientifica”.
Cosa diceva il documento?
Il documento della SIMA sottolineava una relazione diretta tra il numero di casi di COVID-19 e l’inquinamento dell’aria nella zona dove quei casi si sono manifestati. In altre parole: quanto più l’aria è inquinata, tanto più numerose sono le persone contagiate. Per arrivare a queste conclusioni, il documento analizzava lo stato di inquinamento da “Materia particolata” (o particolato atmosferico, vale a dire l’insieme delle sostanze sospese in aria sotto forma di aerosol atmosferico) dei territori maggiormente interessati dall’epidemia di Covid-19.
D’accordo: ma esiste una relazione diretta tra inquinamento atmosferico e aumento dei casi di Covid-19?
A questo proposito, alcuni noti ricercatori italiani hanno commentato la metodologia di rilevazione dei dati usata dalla SIMA [2]. Anche la Società Italiana di Aerosol (SIA) ha espresso un parere sulle conclusioni della SIMA ricordando che l’esposizione ad alte concentrazioni di particolato aumenta la suscettibilità a malattie respiratorie croniche e cardiovascolari e che questa condizione può peggiorare la situazione sanitaria dei contagiati. Le alte concentrazioni si osservano frequentemente nel nord Italia, soprattutto nella pianura Padana, durante il periodo invernale. “Tuttavia, ad ora non è stato dimostrato alcun effetto di maggiore suscettibilità al contagio alla Covid-19 dovuto all’esposizione alle polveri atmosferiche.”
C’è un altro elemento nel documento della SIMA che dovrà essere approfondito: la possibilità che il particolato atmosferico possa – per così dire – agevolare il trasporto del virus aumentando di conseguenza il ritmo del contagio. “Questo aspetto non è però confermato dalle conoscenze attualmente a disposizione” afferma la SIA, “così come non sono ancora del tutto noti il tempo di vita del virus sulle superfici e i fattori che lo influenzano” [3]. Le condizioni meteorologiche tipiche del nord Italia nel periodo invernale, quali la bassa temperatura e l’elevata umidità atmosferica, potrebbero creare un ambiente che favorisce la sopravvivenza del virus. “Queste condizioni che, in genere, coincidono con una situazione di stabilità atmosferica intensa, favoriscono la formazione di particolato secondario e l’incremento della concentrazione del PM in prossimità del suolo” [3].
Tornando alla possibilità che l’aria inquinata possa “trasportare” il virus, si è espressa con determinazione al riguardo anche la Rete Italiana Ambiente e Salute (RIAS) [4]: “Questa ultima ipotesi non sembra avere alcuna plausibilità biologica. Infatti, pur riconoscendo al PM [particolato atmosferico, ndr] la capacità di veicolare particelle biologiche (batteri, spore, pollini, virus, funghi, alghe, frammenti vegetali), appare implausibile che i coronavirus possano mantenere intatte le loro caratteristiche morfologiche e le loro proprietà infettive anche dopo una permanenza più o meno prolungata nell’ambiente outdoor. Temperatura, essiccamento e UV danneggiano infatti l’involucro del virus e quindi la sua capacità di infettare. La diffusione non corretta di tale ipotesi, non suffragate da evidenza scientifica, può essere molto fuorviante nella comunicazione del rischio alla popolazione, già disorientata dalla contrapposizione fra ‘distanze di sicurezza’, troppo ravvicinate – se consideriamo la possibile trasmissione aerea via micro-droplets in ambienti chiusi” [4]. Ricordiamo che il termine droplet in italiano vuol dire gocciolina e quando viene usato in contesti scientifici si riferisce alla saliva nebulizzata durante una conversazione, un colpo di tosse o uno starnuto.
Quindi, ha poco senso farsi domande sul rapporto tra inquinamento atmosferico e Covid-19?
Assolutamente no, anzi sarebbe opportuno che questa possibile relazione fosse studiata in modo metodologicamente rigoroso, così da avere “una risposta adeguata e tempestiva per contribuire al progresso della conoscenza per la sanità pubblica” [2]. La ricerca dovrebbe tenere conto di quello che già si sa e che è disponibile nella letteratura scientifica in merito alle relazioni tra ambiente, qualità dell’aria e salute. Allo stesso tempo, la ricerca scientifica sulla Covid-19 sta producendo molte informazioni che possono essere molto utili anche per valutare in modo approfondito il legame tra inquinamento e Covid-19. Ma non sono studi semplici da eseguire.
Perché si tratta di ricerche complesse?
Come hanno spiegato i ricercatori della Rete Italiana Ambiente e Salute [4], bisognerebbe “considerare le principali condizioni locali relative all’andamento della qualità dell’aria, le caratteristiche delle comunità residenti, lo stato di salute preesistente e co-fattori legati sia all’inquinamento sia alla malattia in esame”: ad esempio l’età, le condizioni socio-economiche, le abitudini personali, le malattie concomitanti di cui soffrono gli abitanti delle zone studiate), nonché informazioni sulle misure di contenimento del Covid-19 adottate.
Un altro elemento che introduce ulteriore complessità è la forte probabilità di confondere una associazione con una correlazione: in altri termini, di non cogliere fino in fondo la differenza tra la coesistenza di due problemi e la loro relazione causale. Nel caso specifico, in un territorio in cui per buona parte dell’anno l’inquinamento atmosferico è elevato può aumentare il numero di persone sofferenti di patologie respiratorie nelle quali, qualora contagiate, la malattia può avere un decorso più grave. Ma l’inquinamento atmosferico non può essere considerato di certo la causa della Covid-19.
Ad ogni modo, centri di ricerca molto qualificati stanno conducendo degli studi, alcuni dei quali hanno già prodotto dei risultati che sono ancora allo stato di pubblicazioni preliminari, come nel caso della ricerca della Scuola di sanità pubblica della università di Harvard [5].

Argomenti correlati:
CoronavirusInquinamentoPrevenzioneRicerca