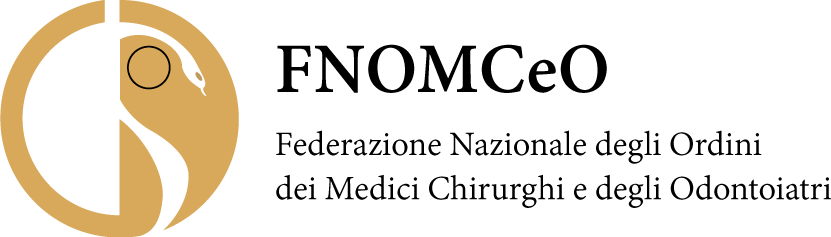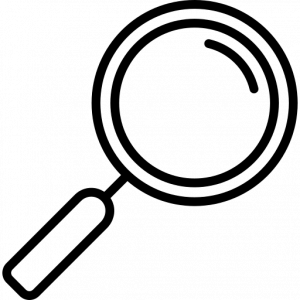Il modo con cui tradizionalmente chiamiamo i diversi tumori, cioè col nome dell’organo dove si sono sviluppati, non è solo superato alla luce delle conoscenze odierne, ma ha anche un impatto concreto non indifferente sull’accesso dei malati di cancro alle cure.
Il modo con cui tradizionalmente chiamiamo i diversi tumori, cioè col nome dell’organo dove si sono sviluppati, non è solo superato alla luce delle conoscenze odierne, ma ha anche un impatto concreto non indifferente sull’accesso dei malati di cancro alle cure.
Lo sostiene sulla rivista scientifica Nature un gruppo di ricercatori francesi, secondo cui continuare a pensare alla malattia in termini di “tumore all’ovaio”, “al seno” o “al polmone” potrebbe essere già costato centinaia di migliaia di vite [1].
Dottore, di questa “rivoluzione” si parla da un po’?
La provocazione forse è un po’ esagerata nelle sue conclusioni, ma è concettualmente corretta e condivisa dalla comunità scientifica internazionale. Parlare di cancro al polmone, al seno o al colon, infatti, porta a credere che a ciascuna di queste definizioni corrisponda un’unica malattia, da cui conseguono tipi di trattamento e aspettative di sopravvivenza e guarigione. Da molto tempo sappiamo invece che non è così: in ogni organo ci sono diversi tipi cellulari, riconoscibili al microscopio, da cui può avere inizio la trasformazione neoplastica e da cui può dipendere la maggiore o minore efficacia delle terapie tradizionali, come la chemioterapia.
 Negli ultimi decenni, tuttavia, una conoscenza sempre più approfondita delle caratteristiche molecolari dei singoli tumori, dei meccanismi che li alimentano dall’interno e di quelli che rendono loro favorevole l’ambiente circostante ha permesso di rivoluzionare l’approccio al cancro, rendendo la terapia sempre più personalizzata. Oggi sappiamo che due persone con malattie apparentemente diverse, ma che dipendono dalla stessa mutazione, rispondono alle stesse cure, mentre tumori sviluppati nello stesso organo, con marcatori differenti, possono richiedere terapie molto diverse.
Negli ultimi decenni, tuttavia, una conoscenza sempre più approfondita delle caratteristiche molecolari dei singoli tumori, dei meccanismi che li alimentano dall’interno e di quelli che rendono loro favorevole l’ambiente circostante ha permesso di rivoluzionare l’approccio al cancro, rendendo la terapia sempre più personalizzata. Oggi sappiamo che due persone con malattie apparentemente diverse, ma che dipendono dalla stessa mutazione, rispondono alle stesse cure, mentre tumori sviluppati nello stesso organo, con marcatori differenti, possono richiedere terapie molto diverse.
Non accade ancora per tutti, ma di molti tipi di cancro conosciamo oggi quale può essere il fattore essenziale o determinante per la loro crescita anomala rispetto ai tessuti sani, o per la loro apparente invulnerabilità all’attacco delle difese immunitarie. Questi fattori sono in genere molecole anomale, o prodotte in quantità diversa dalla norma, in seguito a una mutazione genetica o a un riarrangiamento cromosomico, che le terapie mirate vanno in vario modo a neutralizzare. I tumori che rispondono a ciascuna di queste cure sono quindi riconoscibili per la presenza di marcatori contrassegnati da sigle come HER, BRCA, BRAF, KRAS, RED, EGFR, MET, ALK – solo per citarne alcune – eventualmente accompagnate da altre lettere o numeri che definiscono il tipo di mutazione presente.
Dottore, ma in che senso il nome del tumore influisce sulle cure?
 Tutti questi sono concetti ben noti a chi si occupa di cancro. La provocazione degli autori del commento inviato a Nature va però oltre, arrivando ad affermare che non aver trasferito questi concetti acquisiti in cambiamenti concreti stia danneggiando l’oncologia e in definitiva soprattutto i pazienti. Le società scientifiche, i congressi, i reparti ospedalieri, i medici e gli specialisti si formano e sono ancora organizzati pensando alla sede del tumore da curare: addominale, toracico, della testa e del collo e così via.
Tutti questi sono concetti ben noti a chi si occupa di cancro. La provocazione degli autori del commento inviato a Nature va però oltre, arrivando ad affermare che non aver trasferito questi concetti acquisiti in cambiamenti concreti stia danneggiando l’oncologia e in definitiva soprattutto i pazienti. Le società scientifiche, i congressi, i reparti ospedalieri, i medici e gli specialisti si formano e sono ancora organizzati pensando alla sede del tumore da curare: addominale, toracico, della testa e del collo e così via.
Può così capitare che una mutazione come quella del gene RET, rara in un tumore del pancreas, ma per cui esiste una cura, rischi di non essere presa in considerazione e cercata da chi si occupa sempre di questo organo, mentre verrebbe subito in mente a chi tratta abitualmente la tiroide.
O, addirittura, può succedere che il paziente non possa accedere alla terapia. Il medicinale mirato a questa alterazione, per esempio, si chiama selpercatinib, e solo nel 2022 la Food and Drug Administration statunitense ha esteso la sua autorizzazione a tutti i casi in cui la malattia avanzata dipende da una mutazione del gene RET, indipendentemente dall’organo da cui è partita [2].
Un caso ancora più clamoroso è quello del nivolumab, uno dei primi farmaci che hanno determinato la svolta dell’immunoterapia moderna. Già uno studio del 2012, infatti, suggeriva che fosse efficace nel 20-25% dei pazienti con malattia in fase avanzata, indipendentemente dal fatto che avessero un melanoma, un cancro al polmone o al rene, ma con un successo che sembrava andare di pari passo con l’espressione di una proteina chiamata PD-L1 da parte dei diversi tipi di cellule tumorali [3].
Poiché l’approvazione delle autorità regolatorie, le indicazioni delle linee guida, i rimborsi dei servizi sanitari e delle assicurazioni avevano sempre proceduto per organo colpito, i trial successivi misero però alla prova il farmaco malattia per malattia, partendo da quelle per cui esistevano meno opzioni terapeutiche, come melanoma, mesotelioma o alcuni tumori del polmone, mentre le pazienti con tumore al seno o all’ovaio e alta espressione di questa proteina – che pure avrebbero potuto rispondere molto bene al farmaco – hanno dovuto rinunciarvi per anni [4-6].
Classificare i tumori in base al meccanismo molecolare che li alimenta, sostengono i ricercatori francesi, potrebbe poi anche semplificare l’approccio allo studio per gli studenti e all’aggiornamento per i medici, oltre a motivare meglio i pazienti a cui sarebbe facile spiegare che ricevono una cura diretta a un preciso circuito fuori controllo. Infine, aggiungiamo noi, non si creerebbero false speranze nel pubblico quando si annunciano, come se riguardassero tutti i tumori del polmone, risultati che si riferiscono a piccole sottopopolazioni di pazienti con particolari mutazioni.
Dottore, ma che cosa è stato fatto finora?
 Qualche passo è già stato fatto. Il concetto di “indicazione agnostica”, che non guarda all’organo di partenza del cancro ma alla presenza di un bersaglio da colpire, sta entrando a livello delle agenzie regolatorie. Nel 2017, la Food and Drug Administration statunitense ha per la prima volta autorizzato un prodotto per l’immunoterapia, pembrolizumab, per pazienti di qualunque età, con un cancro in fase avanzata di qualunque origine, ma che presentasse determinate caratteristiche molecolari.
Qualche passo è già stato fatto. Il concetto di “indicazione agnostica”, che non guarda all’organo di partenza del cancro ma alla presenza di un bersaglio da colpire, sta entrando a livello delle agenzie regolatorie. Nel 2017, la Food and Drug Administration statunitense ha per la prima volta autorizzato un prodotto per l’immunoterapia, pembrolizumab, per pazienti di qualunque età, con un cancro in fase avanzata di qualunque origine, ma che presentasse determinate caratteristiche molecolari.
Negli anni successivi anche l’Agenzia Europea per i Medicinali e l’Agenzia Italiana del Farmaco hanno preso la stessa decisione, per questo e per un altro farmaco, larotrectinib, indirizzato a tutti i tumori con un altro marchio genetico, indipendentemente da dove sono localizzati. Questi precedenti da parte delle agenzie di autorizzazione “per anomalia”, invece che “per organo” non sono importanti solo per i malati che da subito ne possono usufruire, ma anche per incoraggiare le aziende farmaceutiche a portare avanti nuovi studi con questa diversa prospettiva.
Si stanno poi preparando nuove linee guida da parte delle società scientifiche, mentre è più difficile pensare a una riorganizzazione degli ospedali. Ancora insufficiente, poi, è il numero di pazienti con malattia in fase avanzata il cui tumore è sottoposto a un’analisi genetica accurata, nonostante le raccomandazioni delle società scientifiche di estendere questi esami a tutti i pazienti che potrebbero beneficiarne risalgano a più di dieci anni fa.
Il più grosso ostacolo è rappresentato dal costo elevato di questi test, di cui usufruirebbe poco più del 20% dei pazienti con malattia metastatica nei Paesi ad alto reddito. Talora è proibitivo anche il costo delle terapie da fornire una volta accertata la presenza di un bersaglio. Ciò impone ai servizi sanitari di valutare con rigore, in relazione all’impegno economico richiesto, i vantaggi in termini di sopravvivenza e soprattutto di sopravvivenza libera da malattia garantite da queste medicine, che talvolta fanno miracoli, ma in altri casi aumentano la sopravvivenza media di poche settimane, o devono ben presto cedere alla resistenza che il tumore sviluppa nei loro confronti. La sostenibilità delle cure in un contesto di equità non è un tema su cui si può sorvolare, ma che va valutata con attenzione per la ricerca del maggior bene comune.
Senza dimenticare che esistono ancora molti casi in cui la malattia non ha ancora svelato ai ricercatori il suo tallone d’Achille molecolare: ignorarli non sarebbe corretto.
Argomenti correlati:
Cancro