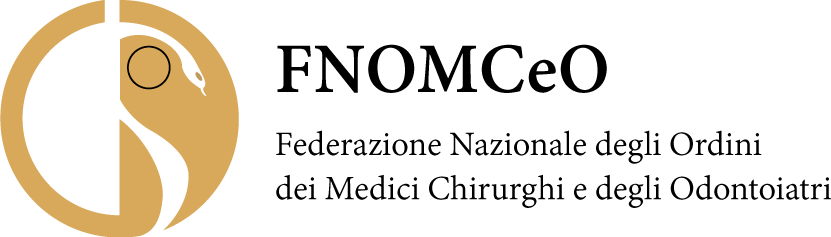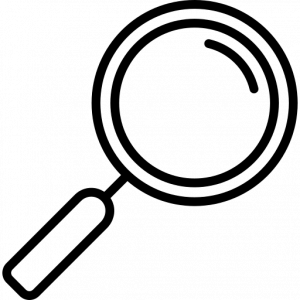Dal 2010 in Italia esiste una cornice normativa chiara che riconosce i Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e tutela gli studenti che ne sono portatori. La Legge 170/2010 rappresenta un punto di svolta: afferma che i bambini e i ragazzi con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia hanno diritto a una didattica personalizzata, a strumenti adeguati e a modalità di valutazione che tengano conto delle loro caratteristiche [1].
Dal 2010 in Italia esiste una cornice normativa chiara che riconosce i Disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e tutela gli studenti che ne sono portatori. La Legge 170/2010 rappresenta un punto di svolta: afferma che i bambini e i ragazzi con dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia hanno diritto a una didattica personalizzata, a strumenti adeguati e a modalità di valutazione che tengano conto delle loro caratteristiche [1].
Alla Legge si affiancano il Decreto Ministeriale 5669/2011 e le Linee guida dell’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (oggi Ministero dell’Istruzione e del Merito), che ne definiscono l’applicazione pratica: come si deve redigere un Piano didattico personalizzato (PDP), quali strumenti devono essere garantiti, come deve svolgersi la collaborazione tra scuola e famiglia [2]. È un insieme di norme che ha trasformato la scuola: non più luogo in cui chi “non riesce” resta indietro, ma spazio in cui ogni studente deve avere la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità.
Dottore, che cos’è la dislessia?
La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento di origine neurobiologica che riguarda la lettura. Non è una malattia né un deficit di intelligenza, ma una differenza nel funzionamento del cervello che rende più difficile leggere in modo fluido e accurato.
Non è corretto dire che oggi ci siano più casi di dislessia rispetto al passato. Già negli anni Cinquanta gli studi di Rutter e Yule avevano rilevato una prevalenza stabile, attorno al 5-8% della popolazione scolastica. Ciò che è cambiato è la capacità di riconoscere la dislessia: un tempo i ragazzi venivano etichettati come “svogliati” o “pigri”, mentre oggi, grazie a strumenti diagnostici più accurati e alla legge, hanno il diritto di essere individuati e sostenuti.
Dottore, ma è vero che la certificazione è importante?
 La certificazione di DSA è il documento ufficiale rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da centri accreditati. È indispensabile perché obbliga la scuola ad attivare le misure previste dalla normativa, a partire dal Piano didattico personalizzato [3, 4]. La certificazione non è una semplice “etichetta”, né deve esserlo. Al contrario è una garanzia di tutela: consente di rendere esigibili i diritti dello studente.
La certificazione di DSA è il documento ufficiale rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale o da centri accreditati. È indispensabile perché obbliga la scuola ad attivare le misure previste dalla normativa, a partire dal Piano didattico personalizzato [3, 4]. La certificazione non è una semplice “etichetta”, né deve esserlo. Al contrario è una garanzia di tutela: consente di rendere esigibili i diritti dello studente.
La legge, tuttavia, prevede che la scuola possa predisporre un PDP anche prima della certificazione, se emergono difficoltà evidenti. Questo significa che il diritto del bambino a non rimanere indietro non può essere sospeso in attesa di documenti formali.
Che cos’è il PDP?
Il Piano didattico personalizzato è il principale strumento che traduce la legge in pratica. Non è un modulo burocratico, ma un progetto educativo costruito insieme da scuola e famiglia, che individua strategie, strumenti e obiettivi pensati per quello specifico studente. Un PDP ben fatto non è un copia-incolla, ma un documento personalizzato, che deve essere letto e approvato con attenzione dalla famiglia.
 Come sottolinea Gianluca Lo Presti, psicologo clinico esperto di apprendimento e membro del Comitato Scientifico di Fondazione Irene Ets, il PDP non è un foglio da riempire in fretta. È un accordo educativo tra scuola, famiglia e studente. È la mappa che orienta strategie, strumenti e obiettivi. All’interno del PDP devono essere indicati:
Come sottolinea Gianluca Lo Presti, psicologo clinico esperto di apprendimento e membro del Comitato Scientifico di Fondazione Irene Ets, il PDP non è un foglio da riempire in fretta. È un accordo educativo tra scuola, famiglia e studente. È la mappa che orienta strategie, strumenti e obiettivi. All’interno del PDP devono essere indicati:
- gli strumenti compensativi (mappe concettuali, computer con sintesi vocale, calcolatrice, audiolibri), che aiutano a superare le difficoltà funzionali;
- le misure dispensative (tempi aggiuntivi, riduzione dei compiti, modalità di verifica adattate), che riducono carichi eccessivi;
- il ruolo della scuola nel predisporre, monitorare e verificare l’efficacia delle misure;
- le modalità di collaborazione con la famiglia, parte attiva e firmataria del patto educativo.
Questi strumenti non sono privilegi o scorciatoie: sono diritti che assicurano equità, permettendo al ragazzo con dislessia di mostrare le proprie competenze senza essere penalizzato dal disturbo. Per tale ragione i genitori devono leggere attentamente questo documento e prendersi tutto il tempo necessario prima di firmarlo.
E se i diritti non vengono rispettati?
 Quando il PDP non viene redatto, rimane incompleto o non è applicato, lo studente rischia di vivere la scuola come un luogo di esclusione. Possono comparire ansia, perdita di autostima e rifiuto scolastico. Le famiglie, in questi casi, hanno diritto a chiedere chiarimenti, a presentare segnalazioni e, se necessario, ad avviare ricorsi presso gli organi competenti.
Quando il PDP non viene redatto, rimane incompleto o non è applicato, lo studente rischia di vivere la scuola come un luogo di esclusione. Possono comparire ansia, perdita di autostima e rifiuto scolastico. Le famiglie, in questi casi, hanno diritto a chiedere chiarimenti, a presentare segnalazioni e, se necessario, ad avviare ricorsi presso gli organi competenti.
Recenti studi internazionali evidenziano come i bambini con dislessia e i loro genitori vivano non solo le difficoltà legate all’apprendimento, ma anche un significativo carico emotivo e psicologico [5, 6, 7, 8]. I genitori, in particolare, riportano livelli di stress più elevati e una qualità di vita spesso ridotta, soprattutto nel momento della diagnosi e durante l’accompagnamento quotidiano. Non sempre hanno a disposizione strumenti metodologici, didattici o risorse psicologiche adeguate.
Per questo è essenziale che anche le famiglie vengano sostenute con figure professionali specializzate, capaci di offrire supporti mirati. In questo modo i genitori possono riprogettare il proprio ruolo, costruendo un modello di relazione più sereno e produttivo, in cui la crescita del ragazzo è condivisa e sostenuta da una rete di alleanze [9]. Un’identità solida nasce proprio da questa coerenza tra ciò che il ragazzo vive a casa e ciò che sperimenta fuori: un intreccio di riconoscimento e ascolto che gli permette di dare valore alle proprie caratteristiche in un confronto con gli altri che non è più competizione ma scambio attivo di prospettive e di sguardi.
Argomenti correlati:
Puericultura