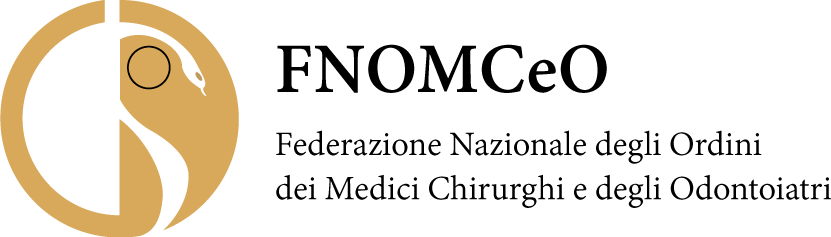Se avessimo poco tempo potremmo rispondere: sì, essere poveri fa male alla salute. Del resto, è qualcosa che è sotto all’occhio di tutti. Si tratta di due condizioni – povertà e salute precaria – strettamente connesse, al punto che è possibile che il rapporto di causa ed effetto tra le due sia in buona misura bidirezionale. In altre parole, molte ricerche in ambiti diversi hanno confermato che le persone che non hanno denaro si ammalano di più ma, in maniera simile, le persone che si ammalano molto spesso vedono diminuire il proprio reddito, fino a diventare povere.
Quali ricerche hanno rivelato questo legame?
Si tratta di un argomento molto studiato, soprattutto dopo la recente crisi economica che ha messo drammaticamente a nudo i dati di un progressivo peggioramento dello stato di salute delle popolazioni delle nazioni più colpite dalle difficoltà economiche.
 Diverse riviste internazionali di medicina si sono interessate a questo problema, in particolare una delle “grandi” riviste mediche, The Lancet, che ha un’attenzione particolare ai temi della salute globale. Grecia, Spagna e Portogallo – leggevamo sulla rivista solo pochi anni fa – hanno adottato una rigorosa austerità fiscale; le loro economie continuano a contrarsi e la tensione sui loro sistemi di assistenza sanitaria sta crescendo. I suicidi e le epidemie di malattie infettive stanno aumentando di numero in questi Paesi e i tagli di bilancio hanno limitato l’accesso all’assistenza sanitaria. Al contrario, l’Islanda ha respinto le politiche economiche improntate all’austerità attraverso un voto popolare e la crisi finanziaria sembra aver avuto poco o nessun effetto visibile sulla salute. Sebbene ci siano molte differenze potenzialmente confondenti tra Paesi è l’interazione tra l’austerità fiscale, la crisi economica e una ridotta protezione sociale quello che alla fine sembra aggravare la crisi sociale e sanitaria in Europa. E, quindi, la salute dei cittadini (Karanikolos, 2013).
Diverse riviste internazionali di medicina si sono interessate a questo problema, in particolare una delle “grandi” riviste mediche, The Lancet, che ha un’attenzione particolare ai temi della salute globale. Grecia, Spagna e Portogallo – leggevamo sulla rivista solo pochi anni fa – hanno adottato una rigorosa austerità fiscale; le loro economie continuano a contrarsi e la tensione sui loro sistemi di assistenza sanitaria sta crescendo. I suicidi e le epidemie di malattie infettive stanno aumentando di numero in questi Paesi e i tagli di bilancio hanno limitato l’accesso all’assistenza sanitaria. Al contrario, l’Islanda ha respinto le politiche economiche improntate all’austerità attraverso un voto popolare e la crisi finanziaria sembra aver avuto poco o nessun effetto visibile sulla salute. Sebbene ci siano molte differenze potenzialmente confondenti tra Paesi è l’interazione tra l’austerità fiscale, la crisi economica e una ridotta protezione sociale quello che alla fine sembra aggravare la crisi sociale e sanitaria in Europa. E, quindi, la salute dei cittadini (Karanikolos, 2013).
Concretamente, una persona più povera vive di meno?
Purtroppo è così: i dati della ricerca ci dicono che l’aspettativa di vita è inferiore nelle persone più povere. Un grande studioso, Sir Michael Marmot, professore di epidemiologia allo University College di Londra e fino a pochi anni fa presidente dell’associazione che riunisce tutti i medici del mondo, ha coniato l’espressione “malattia della povertà” (Marmot, 2016) con la quale intendeva sottolineare che la povertà agisce come una malattia cronica, arrecando danni diretti alla salute di una persona. Possiamo dire che il reddito è un fondamentale “determinante” di salute: “decide” come sarà la nostra condizione, al pari degli altri “determinanti” genetici, biologici e, almeno in parte, culturali.
Qualche esempio?
Lo scarso controllo del proprio lavoro, la perdita di autonomia, la bassa remunerazione e la bassa partecipazione sociale sono fattori associati a un aumento del rischio di sviluppare malattie del cuore o dei vasi – o, per usare un termine più tecnico, una patologia cardiovascolare – con il risultato di maggiori assenze dal lavoro per malattia e maggiore incidenza di malattie mentali.
Dottore, prima citava degli studi svolti in altri Paesi: ma esistono delle ricerche fatte anche in Italia?
 Certamente. Anche nel nostro Paese ci sono dei gruppi di studiosi che lavorano per mettere meglio a fuoco questo problema. Tra questi, una équipe di epidemiologi – i professionisti che studiano la distribuzione delle malattie nella popolazione – dell’università di Torino, coordinati dal professor Giuseppe Costa, che è una vera autorità in campo internazionale. “Tra gli uomini in Italia negli anni Duemila” ha scritto Costa “si osservano più di cinque anni di svantaggio nella speranza di vita tra chi è rimasto in una posizione di operaio non qualificato rispetto a chi è approdato a una posizione di dirigente, con aspettative di vita progressivamente crescenti salendo lungo la scala sociale. Il rischio di morire cresce con l’abbassarsi del titolo di studio; tra gli uomini, fatto uguale a uno il rischio di un laureato, la mortalità cresce del 16% nel caso della maturità, del 46% delle medie e del 78% delle elementari. Questo fenomeno si ripete anche tra le donne e riguarda tutti gli indicatori di salute: ammalarsi, restare a lungo con la malattia e con le sue conseguenze, finire male a causa della stessa malattia” (Costa, 2017 a).
Certamente. Anche nel nostro Paese ci sono dei gruppi di studiosi che lavorano per mettere meglio a fuoco questo problema. Tra questi, una équipe di epidemiologi – i professionisti che studiano la distribuzione delle malattie nella popolazione – dell’università di Torino, coordinati dal professor Giuseppe Costa, che è una vera autorità in campo internazionale. “Tra gli uomini in Italia negli anni Duemila” ha scritto Costa “si osservano più di cinque anni di svantaggio nella speranza di vita tra chi è rimasto in una posizione di operaio non qualificato rispetto a chi è approdato a una posizione di dirigente, con aspettative di vita progressivamente crescenti salendo lungo la scala sociale. Il rischio di morire cresce con l’abbassarsi del titolo di studio; tra gli uomini, fatto uguale a uno il rischio di un laureato, la mortalità cresce del 16% nel caso della maturità, del 46% delle medie e del 78% delle elementari. Questo fenomeno si ripete anche tra le donne e riguarda tutti gli indicatori di salute: ammalarsi, restare a lungo con la malattia e con le sue conseguenze, finire male a causa della stessa malattia” (Costa, 2017 a).
Quindi: non è solo il reddito a incidere sulla salute, ma anche il titolo di studio. E si capisce come siano due aspetti strettamente collegati.
Le differenze nell’aspettativa di vita si riproducono anche a livello locale nelle nostre città. “A Torino chi sale sul tram che attraversa la città dalla collina alto-borghese all’estremo est per andare nella barriera operaia di Vallette, all’estremo nordovest, vede salire dei passeggeri che perdono mezzo anno di speranza di vita ogni chilometro che percorre: più di quattro anni di aspettativa di vita separano i benestanti della collina dagli abitanti degli isolati più poveri del quartiere Vallette” (Costa, 2017 b).
Cosa si può fare per ridurre queste disuguaglianze?
 In Italia abbiamo la fortuna di poter godere di alcuni di quelli che vengono definiti “fattori protettivi”: per esempio, un’alimentazione generalmente ben bilanciata e varia, in parte riconducibile a quella che conosciamo come “dieta mediterranea”. Inoltre, una certa propensione alla protezione sociale attraverso il supporto che viene dall’interno delle famiglie.
In Italia abbiamo la fortuna di poter godere di alcuni di quelli che vengono definiti “fattori protettivi”: per esempio, un’alimentazione generalmente ben bilanciata e varia, in parte riconducibile a quella che conosciamo come “dieta mediterranea”. Inoltre, una certa propensione alla protezione sociale attraverso il supporto che viene dall’interno delle famiglie.
C’è però il grave problema del Mezzogiorno del Paese: i dati dicono che la situazione continua a peggiorare in termini di disuguaglianze. “Ci sono più persone che a causa della povertà di risorse e di capacità stanno peggio in salute, perché il contesto non sa moderare l’effetto sfavorevole della povertà sulla salute delle persone, intendendo come contesto l’ambiente ma anche il funzionamento della comunità e delle istituzioni, compresa la sanità; la concentrazione dei fattori di bisogno dovrebbe guidare meglio le scelte allocative, mentre la difficoltà dei contesti di ‘capacitare’ le persone più povere di risorse è un problema comune a tutte le politiche di sviluppo del Mezzogiorno, a cui la salute disuguale offre un motivo in più per cambiare passo” (Costa, 2017 b).
Come ha ricordato il Presidente della Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Filippo Anelli, “la Legge 833 del 1978 che ne ha sancito la nascita ha fondato del Servizio Sanitario Nazionale su alcuni principi, tra cui l’universalismo e la solidarietà. Ciò significa che a tutti i cittadini va garantita la Salute nello stesso modo, negli stessi termini, con uguali diritti, in ossequio agli articoli 3 e 32 della nostra Costituzione. E vuol dire anche che se un cittadino, o una Regione, si trovano in difficoltà, gli altri cittadini, le altre Regioni devono adoperarsi per aiutarli. Un sistema, dunque, concepito come organico, flessibile, solidaristico” (Anelli, 2018).
È quindi essenziale che lo Stato si faccia carico di un riequilibrio geografico della situazione economica del Paese, perché solo con scelte politiche importanti sarà possibile migliorare l’equità nello stato di salute dei cittadini della nazione.
Argomenti correlati:
DiagnosiMedicinaPrevenzione