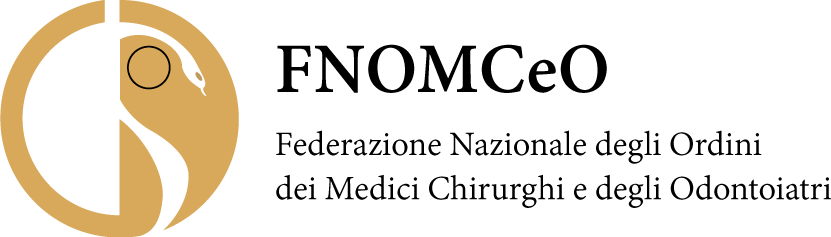La questione è più seria di quanto sembri. La disinformazione, soprattutto sui temi della salute, si comporta davvero come un virus: si diffonde in fretta, cambia forma e può fare danni concreti ai cittadini oltre che alla fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale.
La questione è più seria di quanto sembri. La disinformazione, soprattutto sui temi della salute, si comporta davvero come un virus: si diffonde in fretta, cambia forma e può fare danni concreti ai cittadini oltre che alla fiducia nel Servizio Sanitario Nazionale.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha parlato, negli anni della pandemia, di “infodemia”: una quantità enorme di informazioni – alcune corrette, altre no – che rende difficile capire a chi credere. Il vaccino in questo caso non è una puntura ma una competenza: si chiama alfabetizzazione sanitaria o health literacy.
Dottore, che cos’è l’alfabetizzazione sanitaria?
In parole semplici, è la capacità di trovare, capire e usare le informazioni sulla salute per prendere decisioni orientate e consapevoli, quando si tratta di comprendere cosa mi dice il medico, leggere un referto, usare bene i farmaci, capire a cosa servono visite, esami, screening.
Oggi questo vale anche (e soprattutto) online: parliamo allora di alfabetizzazione sanitaria digitale, cioè la capacità di cercare, valutare e usare in modo critico le informazioni di salute su internet e sui social. Non basta quindi “avere tante informazioni”: bisogna saperle leggere senza farsi travolgere dalla complessità o ingannare dalle promesse di cure miracolose.
Dottore, come siamo messi in Italia?
Purtroppo non molto bene. Secondo l’indagine europea HLS19 (coordinata dall’OMS Europa, a cui partecipa anche l’Istituto Superiore di Sanità):
- in Italia quasi 6 adulti su 10 hanno un livello di alfabetizzazione sanitaria inadeguato o problematico;
- la situazione è peggiore della media europea, sia per chi è in difficoltà, sia per la piccola quota di persone con competenze “eccellenti”.
Dottore, cosa succede se non ho gli “anticorpi” giusti?
 La bassa alfabetizzazione sanitaria non è un problema teorico, ha conseguenze concrete. Chi fatica con le informazioni di salute tende ad avere:
La bassa alfabetizzazione sanitaria non è un problema teorico, ha conseguenze concrete. Chi fatica con le informazioni di salute tende ad avere:
- difficoltà a capire prescrizioni, foglietti illustrativi, istruzioni per farmaci o esami;
- minore aderenza alle terapie (salta le dosi, interrompe prima la cura, si autogestisce);
- peggior controllo delle malattie croniche (come diabete o ipertensione), che richiedono una buona auto-gestione.
Questo ha ricadute importanti per la collettività e per il sistema sanitario, perché ci sono più accessi al pronto soccorso per problemi non urgenti e meno adesione alla prevenzione (screening, vaccini, stili di vita sani) ed in definitiva più complicanze evitabili e costi più alti per tutti.
Dottore, allora qual è la cura?
Da alcuni anni sono nate molte iniziative per diffondere consapevolezza sulle competenze necessarie per navigare in sicurezza; tra essere spiccano le tecniche di “prebunking” basate sulla inoculation theory, con un meccanismo simile a quello delle vaccinazioni, paragone che è stato usato per descrivere l’acquisizione di nozioni utili per distinguere le informazioni false prima che esse ci si presentino, così da riconoscerle facilmente esattamente come succede con gli anticorpi dopo la vaccinazione.
In ogni caso, non esiste una singola iniezione miracolosa, ma un “vaccino combinato” fatto di più componenti che possono e devono lavorare insieme.
La scuola: vaccinare le nuove generazioni
La scuola è il luogo ideale per costruire le difese di base. Serve inserire nei programmi attività che aiutino ragazze e ragazzi a:
- leggere le notizie (non solo di salute) con spirito critico;
- riconoscere le fonti affidabili;
- muoversi in modo consapevole su internet e social.
Le esperienze italiane ed europee (progetti di health e media literacy come la “Scuola che promuove salute” e “Informed Health Choices”) mostrano che questi percorsi funzionano e possono diventare un vero “vaccino di comunità”.
Un sistema sanitario “facile da capire”
Non possiamo chiedere a tutti i cittadini di diventare esperti: deve essere anche il sistema sanitario ad adattarsi. Questo significa formare gli operatori (medici, infermieri, amministrativi) perché usino un linguaggio semplice, spiegazioni chiare, supporti visivi e produrre materiali informativi comprensibili: depliant, moduli, pagine web scritti pensando a chi fa più fatica, non ai tecnici. Un sistema così viene definito “health literacy friendly”: mette le persone nelle condizioni di capire e partecipare.
Strumenti pratici per i cittadini: imparare a “navigare consapevolmente”
Accanto a scuola e servizi, servono strumenti concreti per allenare le difese personali. È qui che entrano in gioco progetti come questo portale dove, se non l’avete già fatto, potete allenarvi nella sezione “Navigazione consapevole” che insegna a valutare le informazioni online con poche domande chiave, per esempio:
- Chi parla? Posso capire chi c’è dietro il sito e qual è la sua competenza?
- Su cosa si basa? Ci sono riferimenti a studi, linee guida, fonti ufficiali?
- È aggiornato? La data è recente o il contenuto è vecchio?
- Vuole informare o vendere qualcosa? La pubblicità è separata dai contenuti?
- Come usa i miei dati? C’è una politica chiara sulla privacy?
Studi condotti dall’Università di Firenze e dall’Università di Udine hanno mostrato che un percorso guidato con questi strumenti migliora davvero la capacità di studenti universitari di valutare le informazioni sanitarie online.
Dottore, qual è la diagnosi finale?
 In Italia la bassa alfabetizzazione sanitaria riguarda la maggioranza della popolazione adulta e ci rende più esposti a disinformazione, peggiori esiti di salute e uso inefficiente dei servizi.
In Italia la bassa alfabetizzazione sanitaria riguarda la maggioranza della popolazione adulta e ci rende più esposti a disinformazione, peggiori esiti di salute e uso inefficiente dei servizi.
La terapia è una cura di comunità, che passa da:
- politiche pubbliche che riconoscano l’health literacy come un vero determinante di salute;
- scuola che insegni a leggere notizie e dati di salute con spirito critico;
- operatori sanitari che diventino “vaccinatori” di fiducia, con una comunicazione chiara e dialogica;
- cittadini che allenano ogni giorno i propri anticorpi cognitivi, imparando a farsi domande sulle informazioni che incontrano.
Il “vaccino” non elimina i virus informativi, ma ci permette di riconoscerli e di non farli proliferare.
Questa scheda è dedicata alla memoria di Marco Masoni, professore dell’Università di Firenze, medico e ricercatore che ha unito sanità, tecnologia e didattica con rara intelligenza e gentilezza.
Il suo lavoro sulla qualità dell’informazione online e sulla “navigazione consapevole” ha mostrato che le competenze si possono progettare, insegnare e misurare. Ci ha ricordato che aiutare le persone a capire non è solo una scelta tecnica, ma un impegno etico, culturale e civile.
Argomenti correlati:
Medicina